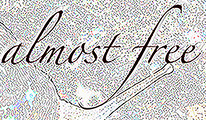10 maggio 2023 h 18.30
Cinema Arsenale Pisa – SALA SAMMARTINO
Temi
Tra realtà e finzione, l’arte dell’illusione
// Povere creature! [Poor things] // Asteroid City // Gli ultimi giorni dell’umanità // Babylon // Everything Everywhere All At Once // Finale a sorpresa // La fiera delle illusioni // Otto e mezzo // The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun // C’era una volta a Hollywood // Notti magiche //
Da tempo non compro giornali cartacei; ho perso l’abitudine (sullo schermo si fa prima a leggere le notizie). Però non ce la faccio a disfarmi dei vecchi settimanali e anche di alcuni quotidiani che hanno acquisito un valore affettivo: La Repubblica il giorno del terremoto in Irpinia, L’Unità il giorno dei funerali di Berlinguer.
Quando vede che li conservo in modo disordinato, C. ripete: «Tu non butti mai niente», e mi guarda con un’espressione del volto che significa: non prenderla come un complimento.
A volte penso che abbia ragione, decido di fare un po’ d’ordine nel caos, comincio a scegliere le cose da buttare, estraggo un vecchio giornale, lo sfoglio … qualcosa mi attrae, mi fermo a leggere e rimando la selezione. Non è detto che a fermarmi sia un articolo di terza pagina: dopo alcuni anni anche la pubblicità diventa interessante. Ciò che prima era banale, fastidioso, è diventato una traccia della vita precedente, apparentemente dissolta nel nulla.
Levo la polvere col piumino per non fare danni; l’aspirapolvere, in un angolo, mi guarda con la stessa espressione di C.: «Aspiriamo tutto? Non ci vuole niente. Basta farli a pezzettini».
«Scusa», rispondo, «non sarebbe meglio, nel caso mi decidessi, metterli nel contenitore per il riciclaggio della carta?».
«Lo dicevo così. Per divertirci».
Ho un aspirapolvere loquace ma scarsamente ecologico.
Se C. vedesse lo studio di Enrico Ghezzi (la registrazione, nel film, risale a qualche anno fa), pieno di libri, riviste e videocassette sparse sui tavoli e negli scaffali, direbbe: «Non butta mai niente».
L’archivio di Enrico Ghezzi è costituito da più di cinquecento videocassette, che ora sono digitalizzate.
L’informatica ha portato ordine, eppure credo che Enrico Ghezzi non abbia rinunciato ai vecchi supporti ingombranti; se ho capito il tipo (conoscendo me stesso) credo li abbia messi da parte, ma non li abbia eliminati. Ai vecchi giornali, alle audiocassette e videocassette, ai libri di carta, ci si affeziona. Non è possibile affezionarsi a una sequenza di zeri e di uno.
Quando sono in vena di malinconia rimpiango la macchina fotografica analogica (si guastò e non la riparai, comprai la prima digitale), le pellicole in bianco e nero; rimpiango l’ingranditore e tutta l’attrezzatura per lo sviluppo, di cui, dopo molte esitazioni, mi sono disfatto, arrendendomi alla mancanza di spazio.
Prima o poi riverserò anch’io le videocassette in un supporto digitale. Dentro ci sono le feste di Natale in famiglia, le feste di fine anno scolastico, ma anche Fuori orario di Enrico Ghezzi. Se avevo un impegno urgente, un lavoro da fare per forza e non potevo stare di notte davanti al televisore, facevo partire la registrazione su una videocassetta di lunga durata, abbassavo il volume, mi spostavo in un’altra stanza, completavo il lavoro mentre la videocassetta si riempiva di Fuori orario.
In un’intervista a l’Unità del 18 agosto 2002 Enrico Ghezzi dice: “Il fuori sincrono oltre che per dis-integrare [col trattino nel testo originale] un po’ l’automatico comunicare televisivo, è nato per comodità, l’ho fatto per telefono dall’India, dal Giappone … È quasi un monologo interiore che diventa esteriore, una piccola “cosa TV” a sé, non un commento”.
Andava così: una premessa stancante, pronunciata a volte guardando da un’altra parte, poi informazioni e concetti interessanti e, infine, non mancava mai una scoperta imperdibile. Conosco alcuni film rari solo perché li ho visti per la prima volta su Fuori orario. Avrei preferito leggere la premessa anziché ascoltarla.
Per fortuna Enrico Ghezzi ha scritto diversi libri attraverso i quali è più facile, o meno difficile, entrare in un pensiero complesso che richiede concentrazione. Sicuramente siamo più abituati a concentrarci sulla parola scritta che sull’ascolto. Verba volant ed è difficile acchiapparle a volo, specialmente se già in partenza sembrano andare per conto loro.
Nell’ultimo libro sono raccolti i testi sulla televisione: L’acquario di quello che manca (Ed. La nave di Teseo, 2021), a cura di Aura Ghezzi con la collaborazione di Alberto Pezzotta. Una raccolta completa, la più completa che si potesse realizzare; testi recuperati dagli archivi dei giornali, ma anche dai famosi scatoloni, di cui parla la figlia, che hanno accompagnato i trasferimenti della famiglia; il primo testo è datato 14 novembre 1978, molti non hanno data, l’ultimo è del 2013: parole assolutamente in sincrono con il tempo in cui sono state pronunciate, anzi precorritrici, alcune strane e deliziose poesie, le interviste concesse in tante situazioni (giornali, incontri, scuole, festival cinematografici).
Nelle interviste Enrico Ghezzi è estremamente chiaro, preoccupato di far capire bene il proprio pensiero a chi gli pone le domande e a chi legge. Quando faceva Fuori orario si preoccupava di creare il gesto televisivo che distinguesse il suo programma dagli altri, che lo rendesse unico.
Riverserò in digitale le videocassette delle feste, i programmi televisivi mitici (si facevano programmi importanti nella Rai3 di Angelo Guglielmi), le commedie napoletane, i film che Enrico Ghezzi ci dava la possibilità di recuperare o di conoscere. Era diventato un amico disposto a darti dei consigli che tu accetti perché sai che è più intelligente di te, anche se a volte non lo capisci. Ma ti fidi. Era l’amico che si materializza dopo una certa ora con la sua pettinatura disordinata e racconta di un film che da quel momento diventa indispensabile.
Non eliminerò le cassette, non eliminerò i giornali. Si ha la sensazione di poter ricavare altro dai vecchi supporti, dopo avere estratto l’informazione più evidente e averla messa sotto forma di una sequenza di zeri e di uno. Il video montato alla buona mettendo insieme Elvis Presley, i canti di montagna, alcune scene di Freaks e la spiaggia dei tamarri è qualcosa di più delle sequenze di numeri che lo codificano e lo rendono immagazzinabile in un hard disk o nel cloud.
Certamente l’informazione digitale non la batte nessuno per l’ordine e per la possibilità di poterla recuperare quando serve.
La raggiungo con poca fatica se decido di occuparmi di un argomento. Ma poi rimane sepolta dentro una casella; in qualche caso sepolta per sempre. Non posso raggiungerla casualmente. È ordinata ma seppellita, come i morti sono disposti in modo ordinato e seppelliti nei cimiteri.
L’informazione analogica è disordinata; se si prova a ordinarla si devono continuamente ridiscutere i criteri di catalogazione. Problema: come ordino i libri? Soluzione: per titolo, per autore, per data, per argomento, per casa editrice, per dimensioni, per colore della copertina, per numero di pagine, per numero di letture e riletture, per intensità del legame affettivo, per grado di difficoltà, per simpatia, per altri criteri. Non sempre si può rispettare un criterio di catalogazione: quel libro dovrebbe andare lì ma nello scaffale non entra; a quell’altro toccherebbe un posto in fondo, fuori mano, o troppo in alto, ma mi piace aprirlo ogni tanto per leggere una poesia; cambio il criterio, devo ricominciare. Da qui il disordine.
Ci si consola pensando al pregio della casualità, che consente di trascorrere un pomeriggio intero in completo rilassamento, leggendo, o leggiucchiando, libri che si sono fatti trovare da soli. Quante scoperte e riscoperte rendono possibili questi pomeriggi poco efficienti ma rilassanti!
Forse Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, gli autori di Gli ultimi giorni dell’umanità, hanno fatto la stessa operazione con l’archivio di immagini conservate nella loro memoria organica (come diceva Umberto Eco), prima ancora che nella memoria minerale (il silicio). Hanno trascorso molti pomeriggi a mettere insieme, una dopo l’altra, immagini provenienti da fonti diverse e si sono divertiti a montarle. Il divertimento traspare, nonostante il titolo disperato.
Dentro al film c’è di tutto; posso provare a fare un elenco di ciò che ricordo, restando molto al di sotto delle cose che ho visto.
Home video della famiglia Ghezzi che hanno lo stesso valore delle mie feste di Natale; si vede il volto sorridente del giovane padre, scene di vita quotidiana della bella famiglia; verso la fine addolora il volto cupo di Enrico Ghezzi ammalato di Parkinson.
Letture dell’amato Kafka; si può dire che il tema complessivo sia il tempo, oltre al cinema come realtà e finzione. Il tempo porta ciascuno di noi, forse l’intera umanità, inesorabilmente verso gli ultimi giorni.
Riprese drammatiche dal G8 di Genova (2001).
Scene tratte da film di autori importanti (è inutile copiare l’elenco dai titoli di coda) inserite in un contesto diverso da quello originale (qui c’è il divertimento).
Registrazione di un incontro con Jean-Marie Straub e Danielle Huillet, registi che non amo ma hanno il merito, secondo me, di avere suggerito uno stile a Ciprì e Maresco: basta vedere l’inizio di Sicilia (Straub&Huillet). Mi riferisco all’incipit perché non riesco a vedere questo film fino in fondo: mi annoia, mi sembra un Ciprì e Maresco troppo lungo e privo di umorismo. Nell’incontro Straub dice una cosa illuminante: «Un film è solo una scuola di percezione e basta. Bisogna essere coscienti e modesti e sapere di cosa si tratta. È uno strumento per aiutare la gente a guardare, a vedere meglio e a sentire meglio».
Lunghi estratti di uno spettacolo di Luca Ronconi che ha lo stesso titolo del film.
Parti di documentari della Nasa: un oggetto spaziale ripreso mentre scende verso la terra affidandosi all’attrazione gravitazionale; noi ci affidiamo alla speranza che prima o poi arrivi e il suo viaggio interminabile finisca.
Eruzioni vulcaniche, fughe di animali, un incendio in un deposito di pellicole accanto a un cinema torinese. Ogni tanto non si capisce se si tratta di riprese reali o di finzioni: sono l’una e l’altra cosa.
La durata di alcune sequenze e la durata complessiva ci sfacchina; i due autori non tagliano mai (il film dura più di tre ore), col risultato di stancare, un po’ come stancavano le premesse a Fuori orario. Però era bello sapere che alla premessa sarebbero seguiti tesori imperdibili, scelti da un amico che ne sa più di noi.
Questo accade anche nel film: la resistenza è premiata da un montaggio superbo che fa scoprire sorprendenti collegamenti fisici e mentali.