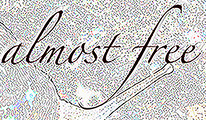4 maggio 2023 h 17.00
Cinema Odeon Pisa – piazza San Paolo all’Orto
Altri film del regista: // Dante // Il Signor Diavolo //
I vecchi
// The Miracle Club // Perfect Days // Adagio (vecchi delinquenti) // Coup de chance e The Old Oak (vecchi registi) // Bassifondi // Scordato // La quattordicesima domenica del tempo ordinario // Il Sol dell’Avvenire // Il ritorno di Casanova // Non così vicino [A man called Otto] // Orlando // Il piacere è tutto mio // Astolfo // Rimini // Nostalgia // Settembre // Belfast // Callas Forever // Cry Macho // Boys // The father [Nulla è come sembra] // Nomadland // LONTANO LONTANO // Le nostre anime di notte (commento al libro) // Herzog incontra Gorbaciov // The Irishman // Dolor y Gloria // Stan & Ollie [Stanlio & Ollio] // Can you ever forgive me? [Copia originale] // Il Corriere [The Mule] // Moschettieri del re // Lucky // Loro // L’ultimo viaggio // Ricomincio da noi // Ella & John //
Amicizia (scoperta, coltivata o tradita)
// Casablanca (Rick e Sam, Rick e Louis) // Bassifondi // Animal House // La quattordicesima domenica del tempo ordinario // La Primavera della mia vita (Colapesce e Dimartino) // Gli spiriti dell’isola (fine di un’amicizia) // Close (l’amico del cuore) // Nostalgia (gli amici si ammazzano, non si dimenticano) // Cry Macho (tra un vecchio e un ragazzo) // Mi chiamo Mattia (racconto) // Lontano Lontano (amicizia tra anziani) // 1917 (amicizia sotto le armi) // Stan & Ollie (amicizia tra artisti) // Copia originale [Can you ever forgive me?] (tra due tipi eccentrici) // Green Book (tra un italoamericano e un afroamericano) // Il mio Capolavoro (tra pittore e gallerista) // Moschettieri del Re (amicizia mitica) // Lazzaro felice (tra emarginati) // The Shape of Water [La forma dell’acqua] (tra individui “diversi”) //
La quattordicesima domenica del tempo ordinario; il calendario liturgico della chiesa cattolica che ora pochi cattolici conoscono.
Pupi Avati: regista, scrittore, credente, cattolico tradizionalista (suppongo), lo conosce.
Una canzone di Pupi Avati e Sergio Cammariere accompagna il film, dall’inizio alla fine. Sui titoli di coda è cantata da Sergio Cammariere.
«Ovunque nella stanza ci son sogni / non realizzati. / S’involano lontano nel silenzio / terre remote. / Le cose belle son fuggite via / dal cielo buio della mia vita. / … / Le tue labbra che cercano le mie / le tue labbra che trovano le mie. / Nel tuo tepore sempre».
Il 24 giugno 1964, quattordicesima domenica del tempo ordinario, secondo il calendario liturgico della chiesa cattolica, Pupi Avati realizzò il sogno: sposò la donna di cui era innamorato, la donna che per lui era la più bella di Bologna. Aveva impiegato quattro anni per convincerla a dirgli di sì. A quei tempi era un sì impegnativo.
Pupi lo ha raccontato più volte. In un’intervista televisiva (Fabio Fazio, Che tempo che fa) ha reso il suo pensiero con le parole seguenti:
«Immagina un drone che sorvola tutta la tua vita. Si ferma su un certo giorno, una certa ora, un certo minuto. 24 giugno 1964 … mi sto un po’ commuovendo … è il giorno in cui mi trovo di fianco una ragazza che ho corteggiato per quattro anni, fino a quando questa ragazza, a mio avviso la più bella di Bologna, non si decide a rispondermi sì. E io me la trovo di fianco e credo che quel momento sia stato il momento più felice del prima e del dopo. Non ci sono più stati momenti come quello. Ecco: il drone si è fermato lì (Pupi fa un gesto con la mano a indicare qualcosa che si ferma in alto). Allora io ho pensato: forse devo rendicontare che cos’è la vita, a ottantaquattro anni – ormai ne so abbastanza – per poi raccontare il percorso, fino a essere in prossimità di quelli che possono essere i titoli di coda della mia vita. Comunque il drone si ferma lì. È un po’ come la stella cometa. Si ferma lì, in quel momento. Ognuno di noi dovrebbe riflettere su quello che è stato il giorno più felice della propria vita. Io racconto questo».
Nel film guarda indietro alla vita sua e dei suoi coetanei bolognesi – non solo coetanei e non solo bolognesi (rivediamo il mago Zurlì, che in televisione conquistò i bambini di tutta l’Italia per molti anni) – sfoglia un album fotografico, rivede i luoghi e i volti conservati nella memoria.
Rivolge lo sguardo soprattutto in direzione di quelli che non ce l’hanno fatta, di quelli che non hanno realizzato il proprio sogno.
Marzio (Lodo Guenzi da giovane, Gabriele Lavia da anziano) sognava di diventare cantante e chitarrista.
Lo è diventato. Ma come?
Fin da quando erano piccoli si era formato un duo, ma Samuele, il compagno dei “Leggenda” (brutto nome per un piccolo complesso, forse il nome spiega il mancato successo) è voluto uscire dal gruppo non appena la speranza di portare una canzone al Festival di Sanremo è naufragata. Samuele ha preferito abbandonare il sogno e tenersi il posto in banca.
È una situazione che si verificava di continuo, in tutti i gruppi musicali che si formavano negli anni sessanta, settanta e primi anni ottanta. Uno mollava – gli altri, i più motivati, stringevano i denti e andavano avanti, con alterne fortune. Alla fine riuscivano quelli che trasformavano il gioco in una professione: continuavano a divertirsi mettendoci l’impegno necessario.
Purtroppo il più motivato dei due Leggenda beveva troppo e aveva problemi nei rapporti con la moglie, che amava troppo.
Si può amare troppo? Sì, è troppo asfissiare l’oggetto del proprio amore e tormentarlo con la gelosia.
Nell’intervista Pupi Avati ha detto: «Mia moglie ha dovuto sopportare le pene dell’inferno per colpa mia!».
Dunque: la data del matrimonio di Marzio e Sandra è la stessa del suo matrimonio, la sposa era la più bella ragazza di Bologna, la gelosia patologica del personaggio è la stessa da cui era affetto Pupi Avati. Stessa gelateria da bambini.
Pupi è diventato un maestro del cinema; Marzio finisce a cantare e suonare in una piccola televisione locale dove interrompono le sue canzoni per pubblicizzare prosciutti, gommisti e ristoranti.
Il personaggio è un fallito; Pupi Avati, che ha cominciato con la musica, si è divertito a rappresentare se stesso in un’altra possibile vita, in un universo parallelo (Everything everywhere all at once). Il film è anche una riflessione su quanto poco separi un uomo che ha avuto successo da un fallito.
Non c’è un momento in cui sul viso di Gabriele Lavia (Marzio anziano) si veda un sorriso. Da ragazzo e da giovane è tutto un ridere, un sorridere a viso aperto verso la vita e verso gli altri, da vecchio è depresso come un cane bastonato.
Si è presentato nello studio di Samuele, presidente di un importante istituto bancario, con un CD e il progetto di far resuscitare il duo Leggenda.
Non ci sta con la testa! Se Samuele avesse accettato avrebbe provocato il crollo delle azioni della banca, la fuga dei correntisti. Chi affiderebbe i propri risparmi a un vecchio che scopre la vocazione di cantante?
Marzio non riesce a rassegnarsi alla fine della giovinezza: il drone, o la stella cometa, si sposta, si porta verso altri lidi. È bello conservare la speranza e la disponibilità, essere sempre pronti a imbarcarsi per nuove avventure, come Ulisse, ma deve soffiare il vento.
La quattordicesima domenica del tempo ordinario (mi piace molto questo titolo) è il terzo film uscito di recente in cui un regista vecchio rappresenta la vecchiaia; ha dentro uno struggimento infinito.
Tutto finisce in un fallimento: l’amore, l’amicizia, il sogno di una vita da rockstar o da cantante popolare, o da modella (la moglie).
Samuele, che ha scelto la banca e non ha avuto scrupoli a portarsi a letto la moglie dell’amico – spinto dalla donna che voleva vendicarsi, attuare la furia distruttiva verso un uomo che non sapeva amare, ma la amava teneramente – finisce prigioniero dei palazzi del potere, poi sale su una sedia per precipitarsi dalla cima di una rampa di scale che sembra fatta apposta per agevolare il suicidio. A sconfiggerlo è la malattia e la morte del figlio.
Pupi Avati, gelosissimo della sua donna (lo ha detto lui), nel film fa andare a letto il personaggio che la rappresenta con l’amico bello – realizza l’incubo che tormenta il cervello dei gelosi – poi si vendica facendolo suicidare. È solo una curiosità: non si può andare troppo avanti con queste interpretazioni psicologiche avventurose. Si può solo aggiungere che il cinema, come i sogni, produce una catarsi, porta all’esterno spinte profonde, come gli incubi. Pupi Avati è autore di importanti film horror. Che cosa sono i film horror se non incubi scovati dentro di sé e rappresentati?
Sandra, la ragazza più bella di Bologna, dopo essersi separata dal marito, essere arrivata a odiarlo, guarisce da una grave malattia e, con l’aiuto di Samuele (cherchez l’argent), riprende il suo lavoro di indossatrice. Poi, al funerale di Samuele, veniamo a sapere che anche con lui si era separata, aveva subito un tracollo economico, aveva perso la casa, si faceva ospitare da un’amica. Fallimento completo di un altro progetto di vita. Nell’universo parallelo rappresentato da Pupi non solo Marzio fallisce, ma anche tutti quelli che gli stanno intorno.
Nelle ultime scene si realizza, per Sandra e Marzio, la speranza di un po’ di pace, prima della pace definitiva. Solo un po’ di pace, nell’appartamento con le pareti ritinturate in blu, per richiamare un momento magico per entrambi.
Pupi Avati sorprende con la scelta degli attori.
Anni fa scoprì e mise in risalto la vena drammatica e la capacità espressiva di un attore che avevamo sempre considerato solo un simpatico caratterista: Carlo delle Piane.
Questa è la volta di Massimo Lopez, in una parte piccola (Samuele da vecchio) molto intensa.
Edwige Fenech è una conferma, non una scoperta: ha avuto esperienze con grandi registi, nei film non ha fatto solo le docce per le quali molti di noi la ricordano; Pupi Avati gioca con questo ricordo in una scena divertente.
Una scoperta è Lodo Guenzi, che finora, come attore, avevo visto solo in un brutto film: EST Dittatura last minute, regia di Antonio Pisu (commento su questo sito). Ammetto di non essere informato abbastanza della carriera di attore intrapresa da questo cantante.
La quattordicesima domenica del tempo ordinario è un po’ il C’eravamo tanto amati di Pupi Avati.
Bisogna dire che i personaggi disegnati da Ettore Scola nel suo capolavoro sono molto più approfonditi di Marzio, Samuele e Sandra; questi ultimi ci lasciano la sensazione di avere acquisito di loro una conoscenza superficiale.
Sappiamo poco della vita di Sandra, solo che desidera ardentemente fare l’indossatrice e liberarsi dell’obbligo di allevare una caterva di figli (all’epoca molte donne si accontentavano di questo obiettivo tradizionale). Sappiamo nulla, proprio nulla, della vita di Samuele (tranne la scena struggente al capezzale del figlio morto); un po’ di più sappiamo di Marzio, ma non abbastanza da capire che cosa gli bolle nella testa.
Alla fine, quando, nel ristorante con Sandra adulta, reagisce nel vecchio modo, quasi in automatico, al sospetto di una provocazione da parte di un giovane, dà l’impressione di essere affetto da paranoia; nell’ultima scena, al ritorno dall’ospedale con la testa fasciata, sembra un derelitto. No, decisamente non capiamo Marzio, il suo comportamento sfocia troppo spesso nella patologia.
In una scena precedente, in chiesa, quando cerca di suonare la chitarra senza il permesso dei parenti del defunto, il suo cervello non gira nel verso giusto dal momento che non è detto, come lui sembra credere, che per Samuele il tempo in cui suonava e cantava nel duo Leggenda fosse il migliore della sua vita: non è detto che il morto, potendo chiedere il suo parere, avrebbe accettato con piacere la sua esibizione.
Di questo personaggio capiamo solo che è un uomo fortemente centrato su se stesso.
La parte più bella (forse la più autobiografica, oltre alle immagini della vecchia Bologna) è il sogno, che forse non è un sogno, in cui Marzio rivede il padre perduto troppo presto e parla con lui, finalmente in piena libertà, finalmente senza la paura di essere giudicato, di essere troppo sincero, troppo indifeso, la paura che ci attanaglia quando parliamo con gli altri.
Si può notare che in questo momento i film italiani più interessanti in circolazione sono fatti da registi che hanno, in qualche caso abbondantemente, superato i sessant’anni.
Negli anni settanta avrei potuto indicare almeno cinque giovani registi italiani (veramente giovani, non come i cinquantenni di oggi) non solo promettenti, ma affermati.
I registi più interessanti sono sempre i soliti, gli stessi che allora erano giovani e ora fanno film che ricordano C’eravamo tanto amati.