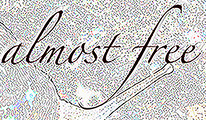9 ottobre 2023 h 17.30
Cinema Spazio Alfieri Firenze – via dell’Ulivo, 6
Temi
I giovani
// Sick of Myself // Io Capitano // Animal House // Next Sohee // Close // Chiara // Penguin Highway // 1917 // Jojo Rabbit // Un giorno di pioggia a New York // La paranza dei bambini // Roma // Mirai // La terra dell’abbastanza // Lady Bird // Alla ricerca di Van Gogh //
Psicanalisi (“The doctor is in”)
// Frammenti di un percorso amoroso // Sick of Myself // Beau ha paura [Beau is afraid] // Preparativi per stare insieme … // Tre piani // Un divano a Tunisi // Doppio amore [L’amant double] //
Un caso di narcisismo e autolesionismo.
Sick of Myself fu presentato al Festival di Cannes 2022 nella sezione “Un Certain Regard”.
Signe è una bella ragazza scandinava. Ha un lavoro, una casa, un compagno: Thomas. Apparentemente non le manca nulla. Eppure Signe soffre: non riesce a essere, come vorrebbe, al centro dell’attenzione. Il suo problema è accentuato da una relazione sbilanciata con Thomas, anche lui in continua ricerca di ammirazione. Thomas è superficiale, vuoto come una campana, ma riesce a richiamare su di sé l’interesse degli altri. I due sono in perenne conflitto, con Signe sempre perdente: lui al centro dell’attenzione, lei in un angolo, ignorata.
Thomas è un narcisista sadico: si gode la vittoria che conferma l’amore per se stesso e finge di non notare l’umiliazione della sua compagna. C’è da chiedersi come mai Signe non lo mandi a quel paese.
Probabilmente nell’infanzia Thomas è stato pompato dai genitori («Come sei bello! Come sei intelligente!). Signe ha percepito delusione nei suoi confronti, trasmessa con l’atteggiamento, con lo sguardo.
Sono solo ipotesi, perché il film non ci fa dare un’occhiata all’infanzia dei due. Però c’è un indizio: lei odia suo padre e quando teme di morire sogna un funerale a cui gli sia impedito di partecipare.
La madre sembra fuori dal mondo: quando Signe comincia a star male la indirizza verso la medicina olistica. L’espressione suona bene: medicina olistica. Nella realtà del film, forse anche nella realtà delle chiacchiere diffuse, si risolve nelle farneticazioni di un guru.
Thomas fa l’artista, nel senso che riunisce pezzi di design (soprattutto sedie e poltrone), crea nuove combinazioni e le mette in mostra. Siamo a Oslo, dove pare che queste esibizioni siano considerate arte moderna (anche in Italia succede).
Thomas non ha abbastanza denaro per comprare le suppellettili che utilizza per realizzare i suoi assemblaggi. Nessun problema: le ruba. È un estroverso, dunque non pone ostacoli tra il pensiero e l’azione. Signe si fa trascinare.
Mentre i due sono a cena in un ristorante, insieme ad altre persone attente a ciò che Thomas dice, Signe, ignorata da tutti, mangia di proposito alcune noci, pur sapendo di essere allergica alla frutta secca. Forse non è allergica e finge il malore successivo, ma finalmente riesce ad attirare l’attenzione su di sé.
Quando il cameriere aveva chiesto «Qualcuno soffre di allergie?» e, nel silenzio degli altri, Signe aveva detto «Io: alla frutta secca», era riuscita a far convergere sulla sua persona l’interesse generale.
Fino a quel momento era trasparente, nessuno l’ascoltava. Poi si è sentita male o ha finto di sentirsi male e finalmente gli altri si sono accorti di lei. Signe ha scoperto che la malattia ci mette al centro del mondo e il nostro piccolo mondo si può allargare. Tutti scopriamo, fin dall’infanzia, questo aspetto della vita. La malattia di un bambino può avere origine psicosomatica: può essere un richiamo, una richiesta di attenzione. Signe vive in una città molto fredda, da diversi punti di vista; lavora in un bar. Vediamo passare davanti alla vetrina del bar un grosso cane; sentiamo urli e un abbaiare furioso. Una donna sanguinante entra barcollando nel bar e cade a terra svenuta. È stata morsa dal cane. Nell’aiutarla, Signe si sporca di sangue.
Nel tragitto verso casa, con la camicia e il volto macchiati di rosso, nota che tutti la guardano, finalmente.
È ciò che desidera: non essere ignorata (come “a real nowhere man” dei Beatles) in un mondo nel quale apparire è esistere, indipendentemente dal motivo per il quale gli altri ti notano, su internet, sulle riviste patinate, in televisione.
Signe cerca di farsi mordere da un grosso cane lupo, pacioso e tranquillo. Il suo tentativo è interrotto dall’intervento del padrone del cane.
Fino a questo momento si erano manifestati disturbi relazionali con i quali tutti abbiamo fatto i conti nell’adolescenza. I disturbi diventano sintomi di malattia se si cerca una soluzione alla sofferenza procurandosi altra sofferenza.
Qui il regista fa un passo che potrebbe risultare avventato per portare avanti la sua tesi: vuole farci intendere che una ragazza infelice possa provocare un grosso cane lupo al solo scopo di trovarsi al centro dell’attenzione.
A me sembra inverosimile, però bisogna aggiungere che i pregi e i difetti di un film (o di un romanzo) non dipendono da ciò che il regista inventa ma da come ce lo racconta. Chi ha letto La metamorfosi di Kafka sa che possiamo immedesimarci in un commesso viaggiatore che un mattino, al risveglio da sonni inquieti, si ritrova trasformato in un grosso insetto. Mentre leggiamo vediamo agitarsi le zampette di Gregor Samsa, del grosso insetto che è diventato.
Kristoffer Borgli è un regista bravo a raccontare.
Signe inizia un percorso di autolesionismo. Scopre su internet un farmaco russo tolto dalla circolazione perché produce gravi danni alla pelle. Tramite un amico che frequenta la parte oscura del web si fa portare a casa una grande quantità di quel farmaco in pillole e comincia a ingerirle.
Sul volto si formano lesioni.
Ingoia altre pillole: le lesioni si aggravano e si estendono al resto del corpo. Questi segni a me ricordano, per analogia, i tatuaggi che ricoprono il collo, il petto, le gambe e le braccia, la pancia di tanti giovani. Mi ricordano i piercing infilati nella lingua, nel naso, nei capezzoli, nell’ombelico.
Il film coglie un aspetto autodistruttivo presente in larga parte della gioventù attuale, la cui manifestazione più evidente, almeno simbolica, sono i tatuaggi e i piercing. I tatuaggi non consentono ripensamenti, i piercing sono probabili veicoli di infezioni.
Signe fa una cosa analoga, anche se molto più pericolosa (ma il gesto è quello): introduce nel corpo un farmaco che causa eruzioni cutanee sempre più gravi ed estese.
Con questo non voglio dire che tatuarsi equivale ad avvelenarsi e non credo che il tatuaggio produca gli stessi danni di un farmaco russo vietato. Forse produce danni minimi, ma non credo faccia bene alla pelle, fermo restando il diritto di ciascuno di fare quello che gli pare della propria pelle, del proprio naso e del proprio ombelico.
Signe non si cura, non rivela ai medici la causa della malattia. I danni che man mano si producono non le bastano: continua a ingerire pillole.
Il volto si deforma sempre di più. Partecipa inutilmente al gruppo suggerito dalla madre, guidato dal guru.
La psicanalisi segue un percorso complicato e non promette guarigioni. Lo psicanalista parla poco, non indirizza il paziente su una determinata soluzione.
Se il “guaritore” parla molto è un guru, al quale indirizzerei una divertentissima canzone di Riccardo Pazzaglia: “Me ne vado a fare il guru” (si trova su YouTube).
Signe riesce a ottenere un articolo su una rivista molto diffusa che porta in copertina il suo volto deturpato. È felice quando sfoglia la rivista con l’intervista e le foto, felice quando la gente comincia a riconoscerla per strada, infelice quando la notizia di un assassinio sposta l’articolo, nella versione online della rivista, in fondo alla pagina.
Contatta un’agenzia che, con la scusa dell’inclusione, sfrutta le ragazze che non rispondono ai canoni classici della bellezza o sono affette da handicap fisici e le propone come modelle. Una modella è cieca, un’altra ha una mano atrofizzata. Il corpo di Signe subisce trasformazioni sempre più pesanti: perde i capelli, grumi di sangue e di pelle ricoprono il volto e il collo, vomita sangue. Finalmente è riuscita a godere del quarto d’ora di celebrità che Andy Warol promise a tutti, sperando che non sia l’ultimo quarto d’ora della vita, come è probabile nel caso di Signe.
La storia è paradossale. Il regista la sa raccontare, sa renderla credibile e riesce a catturare l’attenzione degli spettatori (almeno la mia) dall’inizio alla fine.
È un po’ come se Gregor Samsa si fosse trasformato volontariamente in un grosso insetto per farsi notare, per uscire dalla vita grigia e anonima del commesso viaggiatore; è come se “l’uomo dei lupi” avesse raccontato a Freud il suo incubo (i lupi lo guardavano dai rami di un albero) non per liberarsi ma per finire nella letteratura psicoanalitica.