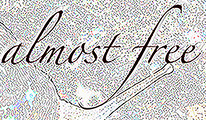11 settembre 2023 h 16.15
Cinema Flora Atelier Firenze – piazza Dalmazia, 2r
Altro film del regista: // Dogman //
Politica, temi sociali, visioni del mondo
// Un altro ferragosto // Palazzina Laf // Io Capitano // Animali selvatici [R.M.N.] // Silent Land // Il Sol dell’Avvenire // Next Sohee // Triangle of sadness // L’homme de la cave [Un’ombra sulla verità] // Parigi, tutto in una notte // La moda di abbattere le statue (articolo) // Alice e il sindaco // Tel Aviv on fire // Vice L’uomo nell’ombra // Benvenuti a casa mia [À bras ouverts] // The Post //
I giovani
// Sick of Myself // Io Capitano // Animal House // Next Sohee // Close // Chiara // Penguin Highway // 1917 // Jojo Rabbit // Un giorno di pioggia a New York // La paranza dei bambini // Roma // Mirai // La terra dell’abbastanza // Lady Bird // Alla ricerca di Van Gogh //
La migrazione dal punto di vista dei migranti.
Un film non è un saggio teorico. Matteo Garrone, come tutti gli artisti, è concreto: parte dall’Africa e non punta sui casi estremi, su chi scappa dalla guerra o da un disastro ambientale. Racconta di due sedicenni senegalesi.
Seydou e Moussa non se la passavano male nel loro villaggio. Dormivano su una stuoia e si svegliavano con il chiacchiericcio delle sorelline. Cantavano, partecipavano ai balli collettivi, alle feste tradizionali, sotto le grandi ali protettive della mamma chioccia.
Avevano un sogno, come tutti i ragazzi di sedici anni.
Il loro sogno era: vado in Europa e divento un cantante famoso; i bianchi mi chiederanno l’autografo.
Alzi la mano chi a sedici anni non ha sognato di cambiare la propria vita, di vivere un’avventura. Poche mani alzate.
Da noi l’avventura sognata da adolescenti può diventare una piccola cosa, presto dimenticata. Oppure può essere l’avvio di una vita straordinaria, di una carriera ricca di soddisfazioni, in qualunque campo.
In Africa l’avventura di due ragazzi è l’inizio di una strada in discesa. Risalire al punto di partenza è impossibile.
Solo in sogno si potrà tornare a casa in un momento di disperazione, immaginare che la mamma stia dormendo, accostarsi al suo letto e trovare un attimo di tregua.
Matteo Garrone è pittore figurativo. In ogni suo film ci sono immagini che danno il senso della storia raccontata.
In Dogman l’immagine manifesto rappresenta il piccolo toelettatore di cani che, all’alba, porta sulle spalle il cadavere bruciacchiato dell’uomo violento che ha ucciso.
In Io Capitano siamo dentro alla fila di migranti sulle dune del deserto. Gli uomini e le donne in marcia, ripresi in campo lungo, sembrano formichine.
Una donna non ce la fa; Seydou si ferma per aiutarla. La donna muore. Il ragazzo non può staccarsi dalla fila condotta da una guida indifferente alla sorte di chi segue. Sogna a occhi aperti: vede la donna riprendersi, ringraziarlo, sollevarsi da terra e condurlo tenendolo per mano. Questa immagine rimane impressa nella memoria, appare per prima quando si pensa a questo film. Contiene tutto: la paura del presente, la dolcezza del passato, il desiderio di condurre e farsi condurre dalla mamma verso un futuro sgombro di nuvole.
Torniamo all’inizio, alla vita serena nel villaggio.
I due cugini, amici sedicenni, hanno nascosto in un buco sotto la sabbia i soldi conservati per il viaggio.
È deciso: partiranno.
Moussa: «Hai paura?».
Nonostante entrambi abbiano paura, fanno il primo passo; dopo non si può più tornare indietro: questo è il dramma.
Dopo che sei stato costretto a nascondere i soldi nel buco del culo e i ladroni del deserto li hanno trovati, è troppo tardi per tornare indietro.
Dopo che ti hanno appeso come i capretti al macello e ti hanno torturato per costringerti a rivelare il numero di telefono della tua mamma per minacciarla (mandaci i soldi altrimenti ammazziamo tuo figlio), è troppo tardi per tornare indietro.
Non c’è luce nel viaggio; l’allegria di trovarsi in un’avventura si spegne, rimane accesa solo la speranza di raggiungere la meta, sempre più fioca.
Per i predoni del deserto, per i poliziotti libici, per gli scafisti, quelli veri, i poveri corpi servono solo per essere sfruttati fino all’osso. Non esiste misericordia, nonostante Dio sia invocato come forma di saluto, ringraziato quando si sconfigge l’infedele. Non dev’essere un Dio misericordioso.
Quanto tempo impiegheranno i popoli europei per organizzare l’immigrazione necessaria per la loro sopravvivenza? Non per la sopravvivenza dell’Africa. Per la sopravvivenza dell’Europa.
I giovani europei rimandano la maternità e la paternità. Le coppie preferiscono aspettare per motivi non solo economici, in parte economici: per motivi culturali, legati allo sviluppo della società. Quale donna, quale uomo vuole porsi come unico obiettivo nella vita la famiglia tradizionale? Quale donna, quale uomo si riterrebbe soddisfatto se avesse realizzato unicamente l’obiettivo della riproduzione? È inutile trastullarsi con piccoli incentivi; accettiamo la realtà, l’evoluzione culturale della nostra società; cerchiamo di trasmettere a chi verrà dopo di noi il meglio che questa cultura ha prodotto (cultura, non etnia o ceppo, o qualche altra parola trovata da qualche ministro ignorante nel vocabolario Treccani). Corsi di lingua, di letteratura, rivolti agli immigrati e ai loro figli, per far conoscere la cultura in cui si inseriscono. Insegnare come ci siamo liberati dai tabù religiosi. Insegnare la Costituzione, la libertà, l’uguaglianza di uomini e donne, la separazione tra stato e chiesa. Insegnare il laicismo, che ci ha liberati dalla caccia alle streghe, dall’odio per i non credenti, dalla persecuzione degli eretici, dal concetto di “infedele”. Gli immigrati devono capire chi siamo e quali sono i valori ai quali non rinunceremo mai. Noi facciamo la scelta di aprire le porte; loro fanno la scelta di passare attraverso le porte, di aprirsi ai valori della società in cui vogliono entrare: uguaglianza tra uomini e donne, separazione tra religione e stato, laicismo.
L’operazione compiuta da Matteo Garrone ricorda Il cammino della speranza (1950, regia di Pietro Germi). In quel film il regista rappresentò il punto di vista dei migranti, che allora erano i poveri minatori siciliani rimasti senza lavoro dopo la chiusura delle miniere, costretti a emigrare in Francia.
Avevano ricevuto il foglio di via, erano clandestini, esattamente come i migranti africani di oggi. Come loro non si arrendevano facilmente: derubati, sottoposti a ricatti dai delinquenti, continuavano a camminare in direzione della speranza.
C’è una differenza di fondo.
Negli anni cinquanta un regista generalmente pessimista come Pietro Germi poteva immaginare un gesto di umanità da parte di una guardia di frontiera che reagisce con tenerezza al sorriso di un bambino.
Attualmente nessun gesto di umanità si riesce a immaginare nell’inferno africano: il modo di vivere, l’insieme dei valori di chi controlla e sfrutta e assiste al traffico di esseri umani non comprende la pietà.
Alla fine il ragazzo messo al timone del barcone guarda l’elicottero dei soccorsi, guarda la costa italiana dove stanno approdando e forse si domanda se ne è valsa la pena.
Urla con soddisfazione: «Sono io il capitano»; non sa che dall’elicottero lo stanno registrando (suppongo) e quando sbarcherà lo arresteranno come scafista. I veri scafisti mettono un povero disgraziato al timone di un barcone e il disgraziato diventa un delinquente da perseguitare “in tutto il globo terracqueo”.
Il film è molto rigoroso; solo un particolare mi ha dato fastidio perché mi è sembrato falso: c’è una fontana di troppo. Un muratore idraulico migrante, diretto a Caserta – schiavo sottoposto a torture come gli altri – è troppo bravo e capace di lavorare in modo raffinato, in un ambiente grossolano e brutale. Mi sembra incredibile che in condizioni così precarie riesca a realizzare una fontana come quella che si vede nel film, al servizio del maialone schiavista fornito di donne velate al seguito.
È un’impressione che, per come la vedo io, getta una piccola ombra su una sceneggiatura rigorosa che, in quasi tutto il film, non scende a patti con la necessità di fare spettacolo.
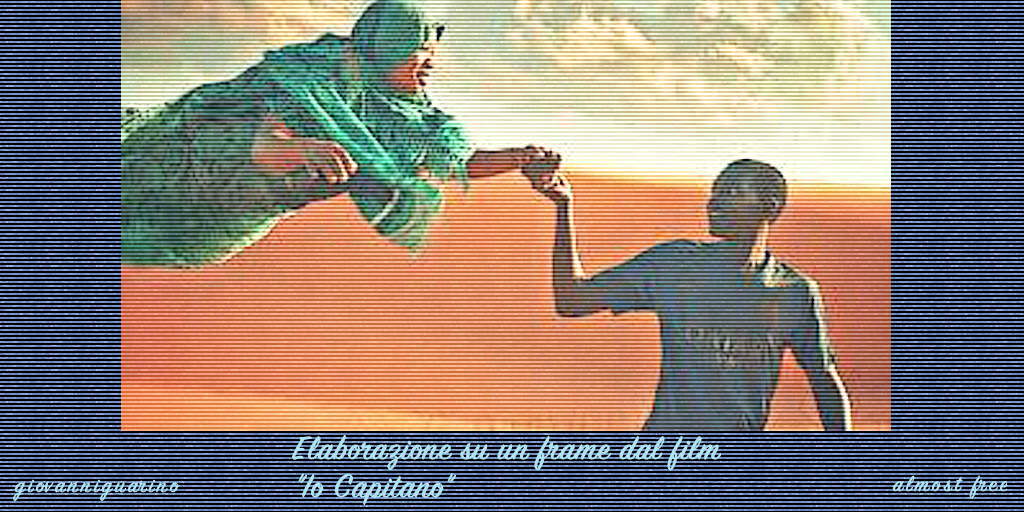
Seconda visione (gennaio 2024)