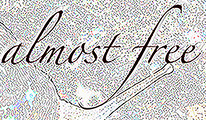11 ottobre 2023 h 17.30
Cinema Spazio Alfieri Firenze – via dell’Ulivo, 6
Ricordi
// Fabrizio Dé André Principe libero // Cinema Moderno (articolo) // Don’t Worry // Un affare di famiglia // Lucky // Il settimo sigillo // Il vizio della speranza // Roma // Vice L’uomo nell’ombra // Un’avventura // La paranza dei bambini // Tutto scorre (articolo) // Il sindaco del rione Sanità // Il Paradiso probabilmente // 1917 // L’illogica allegria (articolo) // Il mare non bagna Napoli (libro) // Dopo la liberazione provvisoria (articolo) // Il Cammino di Santiago (articolo) // After Love // Nostalgia // Come prima // Dante // Umberto Eco La Biblioteca del mondo // Mixed by Erry // Animal House // Frammenti di un percorso amoroso //
Psicanalisi (“The doctor is in”)
// Frammenti di un percorso amoroso // Sick of Myself // Beau ha paura [Beau is afraid] // Preparativi per stare insieme … // Tre piani // Un divano a Tunisi // Doppio amore [L’amant double] //
È una vita che conservo i libri, le lettere, le cartoline, i fogli sparsi.
Conservo un diario intimo che ho scritto a partire dai quindici anni fino a quando nella vita sono entrati i computer e la videoscrittura (seconda metà degli anni ottanta, Olivetti 386). Da quel momento è cominciato un cambiamento radicale che è ancora in corso.
Prima di allora scrivevo nei quaderni, a righi, a quadretti.
Li conservo in una valigia; mi hanno seguito in tutti gli spostamenti. Non un quaderno è andato perduto. Gli altri oggetti si sono salvati o si sono smarriti, a caso, non per importanza oggettiva. In questo momento non saprei dire dove è finita la laurea originale (quando era richiesto il titolo di studio utilizzavo i certificati di laurea); ho davanti a me una vecchissima tessera degli Ostelli della Gioventù. Può sembrare strano che un titolo di studio sia considerato meno meritevole di essere conservato di una vecchia tessera con tanti timbri. Ma tra i timbri c’è la scritta “Ostello Villa Camerata” – Firenze, a cui sono legati ricordi speciali, come si dice a Napoli.
C’è ricordo e ricordo. Tutti sono importanti. Alcuni sono speciali.
Vedo un libretto in cui annotavo le ore di lavoro nel supermercato “Continental”, in Northend road, a Londra, tanti anni fa: ora di inizio, ora di fine, numero delle ore. Ogni sabato, alla fine della giornata di lavoro, passavo da Raje col libretto. Onestamente non mi sentivo sfruttato: ero libero; quando decisi di andar via mi bastò non presentarmi il lunedì successivo; forse feci una telefonata, ma non ne sono sicuro (non c’erano i cellulari).
Ci sono oggetti molto più recenti che conservo con affetto: la locandina della mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” (Livorno, 2019).
Ancora più recente: il biglietto d’ingresso al Giardino di Boboli, martedì scorso. Ci mancavo da molto ed è la prima tappa di un “tour” che ho deciso di fare durante la pandemia, quando eravamo incarcerati in casa e non sapevamo quando ci saremmo liberati; finora ho rimandato ma è arrivato il momento, prima che altri guai impediscano di festeggiare; mi aspetto sempre il peggio: già allora temevo che per anni ci saremmo salutati con quel buffo movimento dei gomiti.
Con l’arrivo sulla scrivania del computer Olivetti 386 (MS DOS 5; per installare Windows 3 dovetti aumentare la RAM) la scrittura nei quaderni si ridusse fino a scomparire.
Avevo accolto volentieri il cambiamento radicale prodotto dalla videoscrittura; mi entusiasmava la possibilità di correggere all’infinito, senza fatica e senza lasciare traccia dei cambiamenti. Mi sembrava comodo conservare il testo, divenuto file, in una cartella virtuale, in un supporto leggero (floppy disk, hard disk, compact disk, dvd), fino a proiettarlo in una nuvola condivisa da milioni di utenti.
Nell’accoglienza a braccia aperte dei cambiamenti interveniva anche il desiderio di divertirsi smontando e rimontando il giocattolo. I primi computer si aprivano, aggiornavano, assemblavano facilmente. Aggiungevamo schede, chip di memoria; sostituivamo l’hard disk e provavamo l’emozione del segnale di avvio, del suono caratteristico che rompeva la tensione: è partito, sta caricando il sistema operativo. A quel punto, finita la fase di carica, si poteva scrivere, ma anche si potevano fare molte altre cose; per esempio lavorare sulle immagini. In seguito abbiamo appreso a “navigare”.
Con la tastiera fisica, poi virtuale sullo smartphone e sull’ipad, si scriveva comodamente. Ma a quel punto mi era passata la voglia di aggiornare il diario intimo.
Non avvertivo il giovamento, la catarsi che si verifica solo affrontando la fatica della penna che striscia sulla carta. L’elaborazione del testo è diventata un esercizio quasi impalpabile, evanescente. Ora, astratto per astratto, preferisco scrivere commenti ai film.
Questi testi svolgono una funzione diversa dal diario intimo: niente catarsi ma ragionamenti e ricordi pescati nella parte della mente a cui ci riferiamo quando diciamo io. Sono pubblici, vanno su due siti.
Il contenuto dei quaderni, invece, è privato e irrazionale, legato ad avvenimenti contingenti (spesso un innamoramento). La spinta a scrivere era la sensazione di stare perdendo l’equilibrio. Scrivevo per ritrovarlo, in un certo senso: per rimettere entrambi i piedi per terra. La scoperta della psicanalisi mi induceva, appena sveglio, ad annotare i sogni (naturalmente leggevo i tascabili della Boringhieri curati da Cesare Musatti).
Cercavo di far uscire le sensazioni, le emozioni, le ansie del momento; cercavo di limitare il controllo. Non avevo l’obbligo di essere chiaro e di non fare errori di grammatica; il patto era: il diario intimo avrà un solo lettore, me stesso.
Risultato: rileggo i testi scritti al computer, ma solo per migliorare lo stile; rileggo ogni tanto i quaderni, lasciando lo stile originale.
Ci sarà un momento in cui, abbastanza vecchio da non avere più futuro, darò un ultimo sguardo al passato, rileggerò tutto e riciclerò i quaderni. Non distruggerò i commenti ai film e le altre cose che metto sul sito; distruggerò il diario intimo, perché riguarda solo il mio rapporto con me stesso.
Da questa lunga premessa si capisce che non potevo mancare il film documentario di Chloé Barreau allo Spazio Alfieri.
Con questa regista condivido il desiderio di fermare in qualche modo il passato. Lei lo fa molto meglio di me, non con i testi ma con le immagini.
Credo che quando ha girato i video non pensasse che li avrebbe utilizzati per fare un film. È passato il tempo e ha avvertito il bisogno di ricostruire una parte della vita, la parte affettiva e sessuale.
Tra me e Chloé c’è una grossa differenza (a parte il sesso, l’età e la sua adolescenza a Parigi): io puntavo, a modo mio, sull’inconscio (privato per definizione, a meno di occuparsi di inconscio collettivo), lei cerca di fare un discorso razionale su un percorso amoroso, visto dalle due parti in gioco.
Si seguono, una dopo l’altra, le immagini di ragazzi e ragazze ripresi quando avevano un rapporto affettivo e sessuale con la regista. Poi li vediamo come sono ora, mentre raccontano come hanno vissuto il rapporto: raccontano il loro punto di vista.
Risultato: una grande malinconia, perché il tempo lavora inesorabilmente su tutti: su Chloé Barreau, sui suoi ex amanti dei due sessi, su di me, sulle ragazze che non ho dimenticato.
Se le andassi a cercare per interrogarle, come ha fatto Barreau, probabilmente resterei deluso e anche loro lo sarebbero. Sono stato innamorato di questa signora? Per lei ho sofferto? Come è potuto accadere?
Anche loro, probabilmente, si domanderebbero: come è potuto accadere?
Eravamo diversi, eravamo giovani.
Meglio che l’amore resti confinato nelle frasi rubate a qualche canzone o a qualche poeta, nei fogli spiegazzati di un quaderno d’altri tempi, nelle lettere scritte per rabbia o per passione, con gioia o con la morte nel cuore, nei tentativi ingenui di leggere le proprie spinte inconsce, di spiegarsi le proprie reazioni e le reazioni delle passanti che per un attimo si sono fermate e ci hanno guardato negli occhi. Un punto di vista soggettivo non destinato a completarsi con un altro punto di vista. È già troppo complicato cercare di capire il proprio.
Les Passantes – dal libro Émotions poétiques (1918) di Antoine Pol; musica Jean Bertola e Georges Brassens.
Le due strofe in nero sono nella poesia ma non sono state inserite nella canzone da Georges Brassens.
Je veux dédier ce poème
A toutes les femmes qu’on aime
Pendant quelques instants secrets
A celles qu’on connait à peine
Qu’un destin différent entraîne
Et qu’on ne retrouve jamais
A celle qu’on voit apparaître
Une seconde à sa fenêtre
Et qui, preste, s’évanouit
Mais dont la svelte silhouette
Est si gracieuse et fluette
Qu’on en demeure épanoui
A la compagne de voyage
Dont les yeux, charmant paysage
Font paraître court le chemin
Qu’on est seul, peut-être, à comprendre
Et qu’on laisse pourtant descendre
Sans avoir effleuré la main
A la fine et souple valseuse
Qui vous sembla triste et nerveuse
Par une nuit de carnaval
Qui voulut rester inconnue
Et qui n’est jamais revenue
Tournoyer dans un autre bal
A celles qui sont déjà prises
Et qui, vivant des heures grises
Près d’un être trop différent
Vous ont, inutile folie,
Laissé voir la mélancolie
D’un avenir désespérant
A ces timides amoureuses
Qui restèrent silencieuses
Et portent encor votre deuil
A celles qui s’en sont allées
Loin de vous, tristes esseulées
Victimes d’un stupide orgueil
Chères images aperçues
Espérances d’un jour déçues
Vous serez dans l’oubli demain
Pour peu que le bonheur survienne
Il est rare qu’on se souvienne
Des épisodes du chemin
Mais si l’on a manqué sa vie
On songe avec un peu d’envie
A tous ces bonheurs entrevus
Aux baisers qu’on n’osa pas prendre
Aux cœurs qui doivent vous attendre
Aux yeux qu’on n’a jamais revus
Alors, aux soirs de lassitude
Tout en peuplant sa solitude
Des fantômes du souvenir
On pleure les lêvres absentes
De toutes ces belles passantes
Que l’on n’a pas su retenir