
12 febbraio 2022 h 18.00
Cinema Arsenale Pisa – vicolo Scaramucci, 2
Ricordi
// Fabrizio Dé André Principe libero // Cinema Moderno (articolo) // Don’t Worry // Un affare di famiglia // Lucky // Il settimo sigillo // Il vizio della speranza // Roma // Vice L’uomo nell’ombra // Un’avventura // La paranza dei bambini // Tutto scorre (articolo) // Il sindaco del rione Sanità // Il Paradiso probabilmente // 1917 // L’illogica allegria (articolo) // Il mare non bagna Napoli (libro) // Dopo la liberazione provvisoria (articolo) // Il Cammino di Santiago (articolo) // After Love // Nostalgia // Come prima // Dante // Umberto Eco La Biblioteca del mondo // Mixed by Erry // Animal House // Frammenti di un percorso amoroso //
Famiglia (mogli, mariti, amanti)
// Settembre // Tromperie // In the mood for love // After love // Drive my car // Otto e mezzo // Illusioni perdute // Cold war // Il filo nascosto // The party // Made in Italy //
Si arrivava a Calais all’alba, dopo un viaggio durato molte ore, dormendo su una delle poltrone che si fronteggiavano nei vagoni dei treni FFSS (Ferrovie dello Stato, dal 2011 abbreviato FS).
In ogni vagone uno stretto corridoio collegava diversi scompartimenti, chiusi da una porta scorrevole.
Lo scompartimento consisteva di due serie di sei poltrone (se ricordo bene il numero) poste una di fronte all’altra, e di un’ampia finestra, che chiamavamo finestrino e con fatica riuscivamo ad aprire e chiudere facendo scorrere il vetro in verticale. La finestra era protetta da una tenda spessa e lunga che si spostava avanti e indietro con movimento orizzontale, scorrendo sugli anelli.
Le poltrone erano munite di poggiatesta. Più in alto, al centro di ciascuna serie, c’era uno specchietto di cortesia.
In uno degli specchi una volta feci la foto seguente.
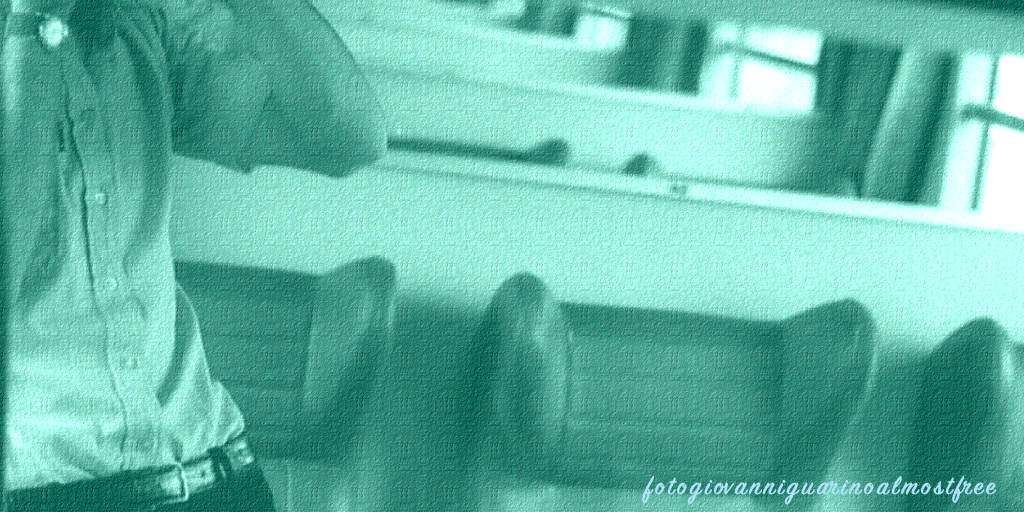
I braccioli che delimitavano la zona laterale dello spazio a disposizione di ciascun occupante si potevano sollevare, eliminando la separazione tra le poltrone.
Con questa operazione era possibile utilizzare la serie come un comodo letto, sul quale – è ovvio – poteva distendersi un solo viaggiatore.
Comodo per modo di dire. Era duro, ma si sa che i letti migliori sono duri: sostengono la colonna vertebrale, evitando di accentuare le curve naturali. Non era formato da un pezzo unico: sotto al corpo disteso si alternavano pieni e vuoti. Era corto per noi che mostravamo lo slancio verso l’alto delle generazioni succedute alle sofferenze e alla malnutrizione della prima metà del novecento.
Eravamo la prima generazione che mangiava la “pastina glutinata Buitoni” (primi Caroselli nel televisore Marelli, ornato con un centrino ricamato), la prima che mangiava la fettina, il formaggino, le fette biscottate, lo yogurt e faceva colazione: una zuppona di latte proveniente non più da Bettina, la mungitrice, ma dal tetrapak pastorizzato. Nei più lontani ricordi, della primissima infanzia, c’è Bettina con la sua mucca, che poi si trasformò nella busta di latte a lunga conservazione.
Su quella specie di letto potevamo distenderci dalla testa al culo, le gambe piegate a formare la sagoma di una montagna, più o meno ripida secondo l’altezza del detentore degli arti inferiori. Sotto alla testa il borsello (accessorio di quegli anni) fungeva da cuscino e proteggeva soldi e documenti.
La possibilità di distendere una parte del corpo, almeno per un po’ di tempo, e di sollevare le gambe era una fortuna; si verificava se eravamo rimasti soli o, al massimo, in due nello scompartimento: capitava nei viaggi lunghi fuori delle feste comandate.
Altrimenti si viaggiava seduti o si allungavano i piedi liberati dalle scarpe fino a raggiungere il posto di fronte rimasto vuoto. In questo caso i più alti erano avvantaggiati.
In questa posizione precaria si riusciva a fare qualche ora di sonno, cullati dal rumore ripetitivo delle ruote del treno, intercalato da fischi prolungati in prossimità delle piccole stazioni sperdute nella campagna, dove il treno non si fermava. Nonostante il dormiveglia, era bello svegliarsi in piena notte, domandarsi per un attimo «dove sono?», guardare fuori dal finestrino, vedere la campagna addormentata, seguire l’arrivo dell’alba: il sole si annunciava con un vago chiarore, poi appariva, superando il profilo buio delle montagne lontane.
Mi dicevo, come faccio sempre (una fissazione): devo ricordare questi momenti, fermarli nella mente. Ed eccomi a ricordarli. Non escluderei di avere scritto qualcosa su uno dei quadernini che ora è difficile recuperare, sepolto in una valigia insieme a tanti altri simili.
Nelle soste il capostazione («quell’uomo in borghese col cappello in divisa», diceva Totò) dava l’avvio col fischietto.
Che fine hanno fatto i vecchi vagoni? Li hanno smontati, fatti a pezzi?
È un peccato avere perso l’occasione di comprarne uno quando le ferrovie li hanno dismessi. Sarebbe stato bello metterlo nell’orto e andarci a dormire d’estate. La parola vagone mi piace: ha il suono di un accrescitivo affettuoso (come amicone, compagnone, furbone, dormiglione) e contiene l’aggettivo vago. Il vagone non è definito una volta per tutte, può essere cose diverse: mezzo di trasporto, riparo provvisorio, casa con le tendine alle finestre (le tende pesanti che si spostavano in orizzontale e scendevano ben oltre le dimensioni del finestrino).
Nell’ultima stazione prima del confine i vagoni che proseguivano per la Francia erano attaccati a un’altra locomotiva, gli altri tornavano indietro; il personale francese sostituiva il personale italiano.
Ero salito a Napoli (provenendo da casa), a Firenze (provenendo dal Youth Hostel Villa Camerata), a Milano (provenendo da Trento).
Tre partenze in anni diversi, con situazioni personali e sviluppi diversi, ma nella memoria si sono fuse in una. La partenza che mi è più cara è l’intermedia, appena dopo la laurea, libero da impegni di studio o di lavoro; fu accompagnata dalla sensazione di assoluta libertà. Portò alla permanenza a Londra più lunga (sei mesi) e si concretizzò dopo una settimana di sosta, dubbio e indecisione vissute nell’Albergo della Gioventù Villa Camerata di Firenze: si trova un po’ fuori mano, rispetto a dove abito ora, verso Fiesole; non mi capita di passarci davanti spesso.
Quando capita mi fermo, percorro quel lungo viale e mi emoziono al ricordo.
Seconda classe, nessuna prenotazione. Non avrei mai prenotato il vagone letto, una sola esperienza mi era bastata: lettini uno sopra l’altro, gente in pigiama e pantofole, cuscino, lenzuolo, coperta di tessuto ruvido (inutile), obbligo di dormire, nessuna finestra sulla campagna o tenuta rigorosamente oscurata per non disturbare i dormienti.
Decisamente il wagon-lit, che, giustamente, Totò chiamava wagon-qui, non era fatto per me.
Il treno mi portò fino a Calais. Forse c’era stato un cambio a Genova o a Torino: non riesco a ricordare. Ho in mente un unico lungo viaggio, senza cambi, da Napoli, da Firenze, da Milano, fino a Calais. Probabilmente nella mia testa è avvenuto un montaggio cinematografico: la memoria ha tagliato pezzi diversi e li ha attaccati con lo scotch (metaforicamente; prima si faceva così con le pellicole, ora fanno tutto al computer). I pezzi, prelevati dai tre viaggi, ne hanno formato uno solo, da quando sono salito in treno a quando sono sceso. La stazione Garibaldi, la stazione Santa Maria Novella e la stazione di Milano si sono fuse in una; si sono mescolati il cappuccino con la sfogliatella e il cappuccino con il cornetto, i rumori, le voci e la musica di fondo.
Ora il film è questo.
A Calais si arrivava all’alba, si scendeva dal treno, si percorreva, assonnati e infreddoliti, un lungo tratto di strada, in processione, fino al traghetto. Non so se la strada fosse realmente lunga: la notte passata quasi in bianco la faceva sentire tale.
Sul percorso si attraversava la frontiera tra Francia e Gran Bretagna; le guardie di confine inglesi ci squadravano, fermavano qualcuno e lo invitavano ad aprire i bagagli. Si saliva sul traghetto per Dover: il controllore del biglietto (un unico biglietto per tutto il viaggio) diceva «Welcome» prima di passare a un altro passeggero.
Sul traghetto mi veniva in mente Le bianche scogliere di Dover (visto di mattina, d’estate, durante la Fiera della casa, quando la televisione trasmetteva i film hollywoodiani); è tratto da un’opera che non ho mai letto; il film non mi pare fosse granché: l’ho completamente dimenticato, tranne il titolo.
Non ricordo l’apparizione delle scogliere: il ricordo non mi è rimasto impresso. Forse non uscivo sul ponte, restavo al coperto, al riparo dal freddo, o ero assonnato. Probabilmente a quel punto, vicino all’approdo, ero preso dai miei propositi, dalle scelte che avrei dovuto fare tra poco (mai programmato un viaggio in vita mia, anche il posto dove avrei dormito la notte successiva era tutto da scoprire).
Quell’espressione – Le bianche scogliere di Dover – mi piaceva; me la ripetevo ogni tanto, tra un pensiero e l’altro, come un mantra, come per dirmi: «Guarda un po’ dove sono!».
Approdati a Dover, si prendeva il treno per Victoria Station, sempre con lo stesso biglietto. A quel punto ero sveglio (l’aria frizzante e la gioventù facevano recuperare il sonno perduto). Nessuna stanchezza, la mente fresca, gli occhi attenti a captare tutto ciò che avveniva intorno e un solo pensiero: «Che bello! Sono nel pieno dell’avventura».
Si tratta, naturalmente, di ricordi remoti: ricordi in bianco e nero (We were black&white people). Il video, in fondo al commento, raccoglie immagini di quel periodo (fine anni settanta).
Ora in Inghilterra si va con l’aereo o attraversando il tunnel claustrofobico. Assai meglio l’aria fresca, la sensazione di avere fatto un lungo viaggio. A che serve tutta questa velocità? Come se accorciando il tempo dei viaggi si guadagnasse un secondo di vita. Che illusione!
Anche un film noioso e poco coinvolgente può suscitare un ricordo importante, il ricordo di quando hai deciso che cosa saresti stato per il resto della vita (molto diverso da ciò che eri stato negli anni precedenti, nella prima adolescenza, claustrofobica come il tunnel sotto la Manica).
Il film noioso e poco coinvolgente è After Love, regia di Aleem Khan; si svolge tra Dover e Calais. L’ho visto in prima visione al cinema Arsenale di Pisa.
Molti primi piani sul volto e, qualche volta, sul corpo iperlipidico (non espressivo come il volto) dell’attrice Joanna Scanlan, che interpreta il personaggio principale.
La trama è semplice.
Ahmed, un pakistano di religione musulmana, ha trovato una soluzione comoda: la moglie a Dover, in Inghilterra, l’amante a Calais, dall’altra parte della Manica, in Francia.
Le due donne non sanno nulla l’una dell’altra: alla moglie dice che ha impegni di lavoro a Calais, all’amante dice che ha impegni di lavoro a Dover. Correggo: all’amante francese, con la quale ha fatto e cresciuto un figlio, ha raccontato di avere una moglie a Dover, ma non l’ha raccontato al figlio.
Naturalmente il figlio adolescente, che ha visto il padre solo quando non aveva “impegni di lavoro”, è un po’ fuori di testa e ha un rapporto complicato con la madre che, per buona parte del film, non sa che Ahmed è morto.
Sì, perché Ahmed, nelle prime scene, muore improvvisamente, mentre, nella casa di Dover, sorbisce un tè preparato dalla solerte compagna della sua vita (una delle due – l’altra sembra poco solerte).
Dopo i riti funebri e il pianto, la vedova guarda nel portafoglio di Ahmed, trova una fotografia, un indirizzo, scopre l’imbroglio su cui è vissuto e l’ha costretta a vivere.
Mary (o Fatima, nome assunto quando si è convertita alla religione musulmana) chiude la casa e va a cercare la famiglia traballante che Ahmed ha costruito a Calais.
Una domanda gira per la testa per tutto il film: come mai queste due donne, in particolare la moglie iperlipidica che si è convertita per amore – mi pare lo dica la stessa Fatima – e ha servito il marito con devozione, rimpiangono quest’uomo egoista?
Ci sono esempi di donne importanti (donne di uomini importanti, in particolare due giornalisti) che hanno accettato per tutta la vita una situazione simile, che a me sembra poco dignitosa.
Le mogli degli uomini a cui mi riferisco, direttori di importanti giornali, conoscevano la situazione e l’accettavano come un fardello, una specie di imposta, suppongo, da pagare all’amore o alla dipendenza, forse non economica ma emotiva. È strano, ma è così: qualcuno rinuncia alla propria dignità per … non so per che cosa; accetta il compromesso e tira avanti: chiama amore la menzogna.
«Mi ami?» «Sì, però con l’altra le cose vanno meglio a letto» «Mi ami?» «Sì, ma con l’altra posso parlare di letteratura, non solo dei lampadari».
La moglie inglese musulmana del film non conosceva la situazione, era ingannata. L’amante francese, certamente non musulmana, in teoria molto più indipendente, conosceva la situazione e l’accettava, facendo un danno al figlio, costretto a stabilire un rapporto precario con una figura paterna che ogni tanto spariva. Il ragazzo, che non sapeva nulla, rimproverava la madre (arrivando a sputarle in faccia) perché l’aveva vista in macchina con il professore di geografia («Sei una puttana, tradisci mio padre mentre il poveretto lavora a Dover!»).
Per quale motivo la moglie, ingannata per tutta la vita, non si ritiene fortunata per la dipartita anticipata di un uomo che, evidentemente, la trattava come una cameriera?
Non c’è risposta nel film. Io ne ho una: ci sono schiavi che si affezionano alle catene.
