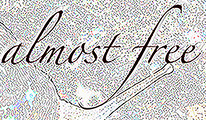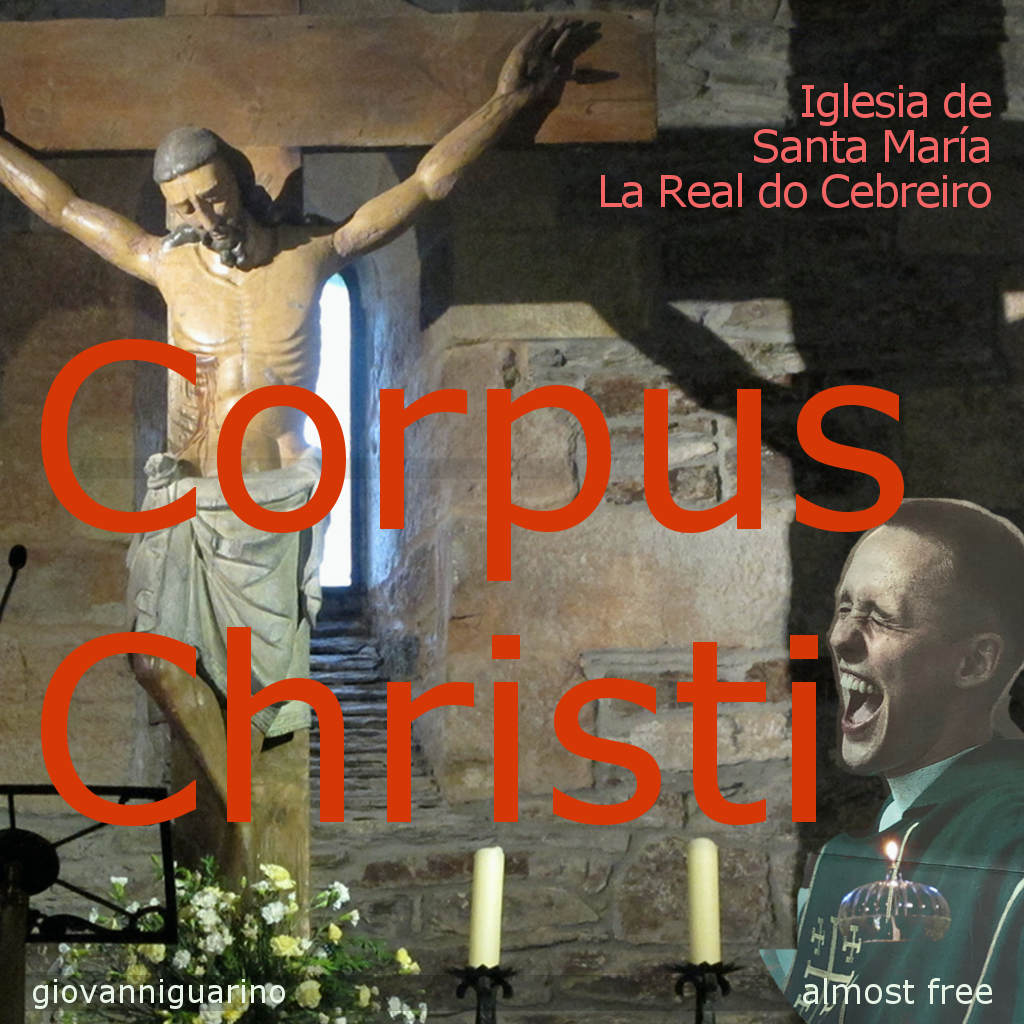
9 maggio 2021 h 17.30
Cinema Odeon Pisa – piazza San Paolo all’Orto
Religioni e/o superstizioni
// The Miracle Club // C’è ancora domani (il matrimonio cattolico) // Kafka a Teheran (Islam) // Rapito (Il Papa Re) // Benedetta (Cattolicesimo) // Holy Spider (Islam) // Profeti (Islam) // Chiara (Cattolicesimo) // Gli orsi non esistono (Islam) // Alla vita (Ebraismo ortodosso) // Il male non esiste (Islam) // Un eroe (Islam) // The Youngest (Ebraismo ortodosso) // Covered up (Ebraismo ortodosso) // Corpus Christi (Cattolicesimo) // Un divano a Tunisi (Islam e psicanalisi) // The dead don’t die (nel commento: fede e dubbio) // Mug Un’altra vita (Cattolicesimo polacco) // Il settimo sigillo (il silenzio di Dio) // L’apparizione (Cattolicesimo) // Cosa dirà la gente (Islam) // Io c’è (religione e denaro) // The Young Pope (Cattolicesimo) //
Nel momento in cui il ragazzo detenuto per omicidio, dopo essersi sottratto alla custodia nel riformatorio, approfittando della libertà vigilata, saluta i parrocchiani riuniti nella chiesa – ai quali si è presentato come prete – si toglie la camicia con il colletto bianco, mostra il torace nudo, i tatuaggi rozzi da carcerato, allarga le braccia come se fosse in croce, in quel preciso momento egli è Gesù Cristo che si avvia verso il sepolcro.
A conferma di questa intenzione del regista, il ragazzo, dopo essere rientrato in carcere, rimprovera il compagno che l’ha denunciato: «mi hai venduto!».
Se c’è Cristo, c’è anche, inevitabilmente, Giuda: riconosce la sua grandezza, lo ama, ma non può fare a meno di tradirlo, perché Cristo lo costringe a confrontarsi con la propria mediocrità: «Tu sai parlare alla gente, sai che cosa dire; io non ho niente».
Forse il Giuda dei Vangeli tradì Cristo per questo: gli invidiava la capacità di parlare alla gente, il talento di farsi ascoltare.
«Cosa credevi, che non ti avrei venduto perché abbiamo fatto insieme una bevuta e abbiamo trascorso una serata da vecchi amici?» gli dice nel film, più o meno, quando lo incontra di nuovo in carcere e lo mette sull’avviso: «domani si fa branco», cioè: domani faranno allontanare il guardiano con una scusa e ti costringeranno a lottare con il fratello dell’uomo che hai ucciso.
Così il ragazzo va incontro alla sua via Crucis, con la quale il film finisce.
Non sappiamo se ci sarà una resurrezione.
No, decisamente nella visione religiosa di questo grande regista non c’è la resurrezione, non su questa terra, in questa vita. Il destino di ciascuno è segnato fino alla fine: chi ha cominciato come assassino sarà costretto a finire come assassino.
Facciamo un passo indietro.
La donna che assiste il vecchio parroco, divorata dal dolore per la morte del figlio in un incidente d’auto che ha distrutto sette famiglie, compresa la famiglia del presunto responsabile, non ha mai accettato questo prete giovane che predica il perdono.
Solo alla fine, quando il giovane se ne sta andando ed è chiaro a tutti che non è un prete – fino a quel momento li ha imbrogliati – lei capisce che quel prete falso è un vero discepolo di Cristo e lo saluta dicendo, fra sé e sé: «Dio la benedica».
Forse è Cristo.
Nelle prediche ricorda innanzitutto quanto siamo deboli e peccatori: «Io sono un assassino», dice. Poi, dopo una pausa, attutisce il significato della frase, la fa diventare metafora, perché non può rinunciare alla finzione.
Non giudica i vivi e i morti, vuole seppellire in terra consacrata l’uomo a cui hanno attribuito la responsabilità dell’incidente, l’uomo che hanno espulso dal cimitero, sul quale riversano tutto il loro odio, e altro odio sulla vedova, isolata e investita con lettere anonime.
Non si sa se quell’uomo fosse ubriaco, come dicono, forse erano ubriachi i sei ragazzi che viaggiavano nell’altra macchina, ma nessuno vuole ammettere la possibilità che l’uomo non fosse il responsabile unico dell’incidente.
La vedova sa che aveva smesso di bere, ma quella sera l’aveva cacciato di casa ed era disperato; la sorella di uno dei ragazzi morti sa che poco prima dell’incidente erano tutti ubriachi.
Nessuno conosce la verità, solo i morti sanno come sono realmente andate le cose.
Il falso prete potrebbe accontentarsi di avere acquisito una condizione comoda (è stato accettato come sostituto del parroco, ha trovato una casa, è lontano dal carcere), ma non può fare a meno di impegnarsi fino in fondo per dare un funerale cristiano al presunto responsabile dell’incidente, per ridare pace ai morti e ai vivi che non riescono a rassegnarsi, ma, soprattutto, non riescono a uscire dalla cappa di odio che li imprigiona.
L’impegno è pericoloso, il mondo ha deciso; il sindaco, il poliziotto, gli abitanti del villaggio, i parenti delle vittime, persino gli adolescenti, che vivono in un mondo a parte, pieno di fumo, hanno abbracciato una tesi che li stabilizza: il male è fuori di noi, è concentrato in un ex alcolizzato, un elemento estraneo, che dev’essere cacciato via, anche dopo morto, anche dal cimitero; la vedova che si ostina a difenderlo dev’essere isolata, costretta a restare chiusa in casa con i suoi sensi di colpa.
Il falso prete non può sottrarsi a questo impegno, perché, attraverso un percorso graduale, sta diventando un vero discepolo di Cristo, o, che è lo stesso, sta diventando Cristo.
Un film potente. Costringe a riflettere. Mi fa piacere averlo visto in questa settimana di liberazione delle sale cinematografiche.
Uno di quei film che spariscono subito dalla circolazione, a cui non si potrà mai attribuire la responsabilità della diffusione di qualunque virus o variante. In un’ampia sala eravamo in quattro: io, un giovane, due signore anziane, più distanziati di quanto si possa essere a casa davanti al televisore.
Mi sono chiesto: se Cristo dovesse tornare tra noi, come si presenterebbe? Come un bel bambino in braccio alla mamma o disteso nella mangiatoia tra il bue e l’asinello?
Mi sembra che Jan Komasa, il regista polacco, suggerisca un’altra possibilità.
Non meraviglia che il regista sia polacco: la riflessione religiosa è sempre stata profonda e drammatica nella cultura polacca, basti pensare a papa Woityla, così diverso dai papi che lo hanno preceduto e seguito, così intenso, sia quando era in buona salute che quando l’Alzheimer cominciò a tormentarlo, sia quando invitava a non avere paura che quando alzava la voce e il dito ammonitore.
Come si presenterebbe Cristo nel mondo di oggi?
Secondo Jan Komasa, credo, si presenterebbe come un ragazzo che ha ucciso per difendersi, conosce la violenza del branco, la vita pericolosa dei giovani che passano il tempo tra droghe leggere e alcol, separati dal mondo degli adulti; conosce la violenza del riformatorio, di cui vediamo un esempio sconvolgente nei primi minuti del film; conosce la violenza del potere, rappresentato dal sindaco proprietario della segheria, sfruttatore dei carcerati, sfruttatore del sentimento religioso, detentore di un dominio che nessuno mette in discussione.
Il giovane recluso nel riformatorio, dallo sguardo rassegnato, ha trovato, nel buio totale, un prete che cerca di aiutarlo; vive un momento di pace solo quando serve la messa.
L’unica possibilità è la libertà vigilata: farsi sfruttare dal sindaco, lavorare nella segheria per una paga misera, senza prospettive.
Esce dal carcere per raggiungere il posto di lavoro. Il giorno successivo a una serata di alcol e sesso, per caso, entra in una chiesa e, sempre per caso, si fa passare per prete.
Dopo il Concilio i preti non hanno una divisa estetica e culturale precisa (l’abito talare, la chierica, il latinorum); basta un colletto bianco, conoscere i canti e i momenti salienti della messa e dichiarare: sono un prete.
Il vecchio parroco, semialcolizzato, non chiede un documento, gli crede.
Gradualmente anche il ragazzo ci crede, si comporta esattamente come dovrebbe comportarsi un discepolo di Cristo, come si comporterebbe Cristo.
Si rivolge all’anima delle persone, non alle loro abitudini.
A una signora che, in confessione, gli rivela di non sapere come controllare un figlio dodicenne, non dà una penitenza ma consigli dettati dall’esperienza di ragazzo sbandato e ribelle.
«Non vuoi che tuo figlio fumi? Compragli le sigarette più forti e digli di fumare»
Quando scopre il dramma che avvolge il paese in una nebbia mortale avverte fortemente l’impegno a dare un degno funerale all’uomo ritenuto responsabile dell’incidente.
Arriva fino in fondo, convince alcuni parenti delle vittime, realizza la cerimonia funebre, si scopre troppo, viene tradito da Giuda e rimandato nel riformatorio.
Qui lo ritroviamo nel pieno della via Crucis.
Sappiamo che si concluderà sul Golgota.
Non sappiamo se al sepolcro seguirà la Resurrezione, ma, dalle ultime scene, insieme al regista, fortemente ne dubitiamo.