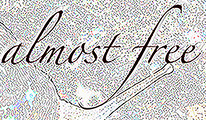13 gennaio 2023 h 17.00
Cinema Adriano Firenze – via Giandomenico Romagnosi, 46
Altro film del regista: // Martin Eden //
Famiglia (genitori e figli)
// Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato // La sala professori (la scuola è un’estensione della famiglia) // Enea // Club Zero // Come pecore in mezzo ai lupi // Ritorno a Seul // Beau ha paura [Beau is afraid] // Miracle: Letters to the President // The Whale // Le vele scarlatte // The Fabelmans // Marcel! // True mothers // Una vita in fuga // One second // Cry Macho // È stata la mano di Dio // Madres paralelas // Raw // Titane // Tre piani // La terra dei figli // Favolacce // Tutto il mio folle amore // Un affare di famiglia // La stanza delle meraviglie // Lady Bird /e/ Puoi baciare lo sposo // Tre manifesti a Ebbing, Missouri //
Nella foto della parete del cinema Adriano, al primo piano, c’è un intruso che sarà rivelato alla fine.
Primi del novecento; famiglia allargata in uno sperduto villaggio della Normandia. Persone estranee si sono incontrate e messe insieme in una fattoria appartata. Si danno una mano ad affrontare le difficoltà della vita. Formano una comunità di mutuo soccorso.
Gli altri abitanti del villaggio li considerano strani, li tengono d’occhio.
Guida il gruppo la personalità carismatica: Madame Adeline, la strega buona.
Si chiama da sé strega; scherza con le altre donne del gruppo: «Noi siamo le streghe». La strega buona nelle favole è la fata. La fata, nella tradizione religiosa, è l’angelo. Madame Adeline è l’angelo della comunità.
Guaritrice, impone le mani, legge il futuro nella polvere di caffè. Alla fine salva le gambe del “temerario sulle macchine volanti”, il pilota di un piccolo aereo caduto nella zona. Su quei giocattoli scavalcavano le montagne, il mare, i deserti. Occorreva tanto coraggio. Se il motore si bloccava mentre erano in volo potevano solo sperare in un miracolo.
Madame Adeline ha accudito dalla nascita la bambina Juliette, figlia di Mary, la ragazza stuprata e uccisa da un prepotente dopo che il marito, Raphaël, è partito per la guerra (la prima guerra mondiale).
I figli dei potenti non andavano in guerra o ci andavano in posizioni privilegiate; solo i poveri erano strappati agli affetti e mandati a morire nelle luride trincee.
Raphaël torna a piedi dalla guerra – i soldati sopravvissuti tornavano a piedi, con gli abiti sbrindellati, i vecchi scarponi, le mani nere, il passo di chi ha macinato chilometri di campagna, distrutti dalla stanchezza.
Raggiunge la fattoria di Madame Adeline, la vedova che ha aiutato la moglie e cresciuto la bambina, sua figlia, nella comunità di uomini, donne, bambini che vivono insieme in una famiglia allargata. Raphaël non conosce la fine terribile di Mary, sa solo che è morta e gli ha lasciato una figlia: Juliette. Quando saprà la verità Madame Adeline lo rassicurerà: è figlia tua, non è figlia dello stupro.
Potrebbe essere una bugia detta a fin di bene. Raphaël dimostra di essere veramente padre di Juliette (padre è chi si comporta da padre).
Raphaël butta nel camino la croce d’onore che gli hanno dato in guerra e cerca un lavoro. È un falegname, bravo scultore del legno, grande lavoratore.
In questo film l’attore francese Raphaël Thiéry ha il volto di Gastone Moschin quando interpretava Jean Valjean nello sceneggiato televisivo tratto da I miserabili (1964, regia di Sandro Bolchi): uno dei migliori prodotti della Rai di quegli anni (Tino Carraro era Javert, Giulia Lazzarini interpretava Fantine e Cosetta).
Thiéry non ha solo il volto di Moschin: ha il suo fisico, lo sguardo, la postura, il modo di muoversi. Se non sapessi che Gastone Moschin, purtroppo, è morto nel 2017, penserei che Raphaël Thiéry sia lo pseudonimo con cui Gastone Moschin, fermo nel tempo, uguale a come era tanti anni fa, ha scelto di interpretare questo personaggio.
Il personaggio ricorda molto Jean Valjean: un pover’uomo della Francia contadina che viene colpito in tutti i modi dai potenti e dai loro servi. Raphaël subisce e non si sottrae alla fatica: china la testa e cammina, china la testa e lavora, fino a consumare tutte le forze. È un “ciuccio ‘e carrèttə”, si sarebbe detto a Napoli, un umile asino addetto al traino del carretto, troppo pesante per le sue forze (il simbolo /ə/ denota la vocale media caratteristica della lingua napoletana).
Raphaël trova un lavoro, poi scopre come la moglie è morta e non aiuta l’assassino impunito e non pentito che sta affogando in un fosso: lo abbandona come merita.
Purtroppo l’assassino non muore ma viene salvato da altri e, da quel momento, Raphaël è isolato nel villaggio. Nessuno ha isolato l’assassino perché ricco e potente, tutti isolano il povero Raphaël, nascondendosi dietro il moralismo ipocrita. Alla fine è licenziato.
Non penso abbia fatto bene ad abbandonare un uomo malvagio che stava affogando. Io non l’avrei abbandonato. Però capisco la reazione di Raphaël al torto subito e non credo che i benpensanti ipocriti abbiano il diritto di giudicare in base ai propri interessi che li portano a perdonare i ricchi e condannare i poveri.
Raphaël riesce a sopravvivere vendendo giocattolini di legno a un negozio in città; ogni tanto prende il treno insieme a Juliette per vendere i suoi lavori.
Juliette cresce. Come gli altri membri del gruppo appartato, come suo padre, subisce l’astio dei paesani. Poiché è donna, subisce anche i rozzi tentativi di approccio dei giovani maschi incapaci di controllare gli istinti. Si difende e sogna l’evasione da quel villaggio privo di prospettive per le donne e per i poveri.
La trama è liberamente tratta dal libro dello scrittore russo Aleksandr Grin (1923).
Raphaël è un faticatore, come si dice a Napoli, ma è anche intelligente e moderno: «Tu deciderai con me, decideremo sempre insieme» dice alla figlia quando la maestra gli suggerisce di mandarla a scuola in città (in quell’epoca nessuna autonomia, nessuna possibilità di scelta davano i padri alle figlie).
Due dettagli di questo personaggio restano impressi: le mani “faticate” (con i segni della fatica), gli occhi chiarissimi, chini sul lavoro, rivolti a terra quando cammina nella folla ostile del villaggio, sollevati in uno sguardo purissimo quando li rivolge verso la figlia. Le dita sono grosse, sembrano di legno; a quelle dita si aggrappa la bambina, poi la giovinetta, per cercare sicurezza. Con quelle dita ritaglia, scolpisce, realizza i giocattoli che gli consentono di affrontare la miseria.
L’ultimo lavoro è la polena di una barca con il volto della donna amata e perduta.
Il racconto è inframezzato da spezzoni di riprese originali, con ricostruzioni di ambiente che mostrano il modo in cui vivevano, negli anni venti del novecento, i nonni di noi vecchi, i bisnonni degli adulti attuali, i trisavoli dei ragazzi di oggi.
È passato poco tempo, solo un centinaio di anni.
La Grande Guerra era finita da poco, con il suo regalo conclusivo: la pandemia spagnola. Altri disastri si facevano avanti: i fascismi, altre guerre.
Nella Francia rurale, come nell’Italia, si doveva pompare l’acqua (vediamo l’attrezzo nel film), i servizi igienici erano inesistenti o approssimativi, il datore di lavoro si chiamava padrone, il lavoro non era un diritto ma un’elemosina, lo stupro commesso da un ricco era considerato errore di gioventù.
In questa situazione: viva le streghe!
Alla fine arrivano le vele scarlatte, come l’altra strega buona, la “magicienne” (maga) aveva preconizzato.
Il povero Raphaël guarisce dalla malattia della vita (finalmente si riposa); dal cielo scende il bell’aviatore avventuriero che porta a Juliette il sogno di un destino diverso.
La parola sogno può avere due significati. In questo film è sinonimo di desiderio. Il sogno di Juliette si realizza; come la maga aveva previsto appaiono le vele scarlatte.
Il film è preciso, poetico. Quasi gemello (soprattutto per lo stile della confezione) del film di Pietro Marcello che mi ha fatto conoscere e apprezzare questo regista: “Martin Eden” (Jack London) trasferito a Napoli.
Un consiglio per chi va a vederlo: abbandonarsi al fluire delle immagini e dei suoni, come da bambini ci si abbandonava al racconto delle favole; c’è tutto: la violenza, l’amore, il sogno.
Vediamo chi è l’intruso nella foto della parete del cinema Adriano di Firenze. Su quella parete, che mi piace molto, c’era uno spazio vuoto; l’ho riempito, non nella realtà, nell’immagine che illustra il commento, con la fotografia del fratello della mia nonna materna. Siccome Pietro non tornò a casa dalle trincee della prima guerra mondiale e il personaggio principale del film, Raphaël, è rovinato dalla stessa guerra, ho voluto fare un omaggio al fratello di mia nonna, di cui sono rimaste solo due fotografie. Una delle due è appesa, in questo commento, alla parete del cinema Adriano, accanto alle immagini di miti del cinema. Forse Pietro, se fosse tornato dalla guerra, sarebbe diventato un grande attore. Chissà!