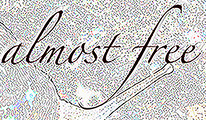1 giugno 2023 h 16.50
Cinema Odeon Pisa – piazza San Paolo all’Orto
Temi
Nuovo Cinema Corea
// Ritorno a Seul // Cane che abbaia non morde [Barking dogs never bite] // Next Sohee // Miracle: Letters to the President // Nido di vipere // Parasite //
Famiglia (genitori e figli)
// Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato // La sala professori (la scuola è un’estensione della famiglia) // Enea // Club Zero // Come pecore in mezzo ai lupi // Ritorno a Seul // Beau ha paura [Beau is afraid] // Miracle: Letters to the President // The Whale // Le vele scarlatte // The Fabelmans // Marcel! // True mothers // Una vita in fuga // One second // Cry Macho // È stata la mano di Dio // Madres paralelas // Raw // Titane // Tre piani // La terra dei figli // Favolacce // Tutto il mio folle amore // Un affare di famiglia // La stanza delle meraviglie // Lady Bird /e/ Puoi baciare lo sposo // Tre manifesti a Ebbing, Missouri //
Un film coreano sulle conseguenze della separazione vissuta in tenera età: “Ritorno a Seul”, regia di Davy Chou. Chi l’ha perso al cinema può trovarlo, volendo, su Apple TV; non si trova su Raiplay, so se sia reperibile su altre piattaforme (alle quali non sono abbonato).
Premessa (due punti).
1) Lunghezza dei post. Ognuno è libero di scrivere quanto ritiene opportuno; chi legge, ovviamente, è libero di interrompere la lettura quando vuole. Due libertà a confronto. La questione finisce qui.
2) Spoiler. Ognuno ha il diritto di sentirsi infastidito dalla lettura dei dettagli della trama; chi scrive ha il diritto di non dare importanza alla cosa. Io, per esempio, credo che non potrei rivedere un film o rileggere un libro se la conoscenza della trama mi togliesse il piacere della visione o della lettura. Eppure rivedo molte volte i film e rileggo molte volte i libri che mi piacciono.
Rivedendo “Gli uccelli” (Alfred Hitchcock) rimango sospeso al finale misterioso, che conosco, alle scene in cui i pennuti vanno all’attacco o preparano un attacco (al piano superiore della casa di Mitch), nonostante le abbia viste molte volte. Credo sia questa la magia del cinema. È una questione soggettiva e si risolve facilmente. AVVISO per chi non ama leggere la trama. Nei righi successivi entro nei dettagli; a me sembra necessario per svolgere alcune riflessioni. Chi patisce lo SPOILER farà bene a interrompere la lettura definitivamente o, se lo riterrà opportuno, fino a quando avrà visto il film.
Veniamo a “Ritorno a Seul”, regia di Davy Chou.
Anaffettiva. È il tratto psicologico principale della ragazza che ha lineamenti coreani ed è sempre vissuta in Francia.
Si chiama Freddie, diminutivo di Frédérique. «Ha i tratti tipici della Corea antica e ancestrale» dicono i nuovi conoscenti quando va per la prima volta in Corea del Sud.
È partita dalla Francia per una vacanza di quindici giorni. Aveva acquistato un biglietto aereo per Tokio. I voli sono stati bloccati da un tifone; la compagnia aerea ha proposto ai passeggeri un’alternativa all’attesa: un volo per Seul in sostituzione del volo per Tokio.
Freddie è in vacanza, non vuole perdere tempo. Ha accettato il volo alternativo. L’evento casuale le ha consentito di scegliere tra due spinte contrastanti, tra desiderio e paura di conoscere il paese in cui è nata.
È nata in Corea del Sud da genitori coreani, in un paese afflitto, in quegli anni, da povertà e sfruttamento, distrutto dalle guerre (la più recente nei cinquanta).
I genitori la diedero in adozione.
Freddie ha 25 anni, ignora completamente la cultura coreana, non conosce la lingua. È molto socievole e, arrivata a Seul, fa subito amicizia con una ragazza che lavora come interprete e le fa da guida agli usi e costumi dei suoi coetanei. Di quegli usi e costumi lei non ha conoscenza. È, a tutti gli effetti, una ragazza francese.
Ha studiato pianoforte, suona da dilettante e ogni tanto, nel corso del viaggio, sentirà una musica lontana. Non è immaginazione; un’altra persona, interrogata da lei, dirà: «È vero, ora che mi ci fai pensare, la sento anch’io». Forse la percezione di Freddie è resa più acuta da un ricordo dei primi mesi di vita.
Questo dettaglio rimane un mistero fino alla fine, quando il regista accende un lumicino senza svelarlo completamente; lascia a noi spettatori la libertà di interpretarlo, ciascuno secondo la propria esperienza e la propria sensibilità.
I bambini dati in adozione erano affidati a un istituto (centro Hammond), poi, seguendo una trafila che poteva durare mesi, raggiungevano i genitori adottivi. Staccati dalla madre, privati di un legame affettivo stabile fino a che si concretizzava la possibilità di affidarli a una coppia adatta, erano soli, accuditi insieme ad altri, ma soli. Spero che attualmente le procedure tengano in maggior conto la sofferenza degli adottandi.
Il regista Davy Chou trasporta nel film un’esperienza autobiografica, inserendo variazioni rispetto alla vicenda personale, a cominciare dal sesso della protagonista.
Mi sono chiesto come mai questo film mi abbia tanto colpito. Sicuramente c’entrano la qualità della regia, la bravura degli attori, ma non solo.
Dopo un paio di giorni sono tornato al cinema Odeon di Pisa per rivederlo. Mi sono seduto in un angolino remoto e, al buio, con un po’ di fatica, ho annotato alcune battute. Non volevo farmele sfuggire. Di solito rivedo i film che mi piacciono, ma non in tempi così ravvicinati.
Mi aveva impressionato l’abilità del regista di rappresentare, attraverso accenni e suggerimenti discreti, il dolore della separazione. È un dolore che conosciamo tutti, anche se non siamo stati separati dalla madre biologica dopo essere venuti alla luce. Abbiamo imparato a metabolizzare la disperazione, a tenerla sotto controllo. È rimasta una cicatrice che ci costringe in difesa, ci fa temere di stabilire rapporti definitivi con gli altri. Abbiamo capito per esperienza, alcuni per esperienza precoce, che non esistono rapporti definitivi: prima o poi resteremo soli come quella bambina separata dalla madre dopo essere venuta al mondo.
Con l’aiuto della nuova amica interprete, incontrata casualmente a Seul, Freddie conosce alcuni giovani coreani.
Sono ragazzi riservati, apparentemente timidi. Dopo il lavoro o lo studio vanno al pub dove passano la serata mangiando piatti tipici (sembra roba fritta), ballando, consumando alcolici. Probabilmente la maggioranza dei giovani coreani ha gli stessi gusti, per esempio in campo musicale, e la stessa idea di svago della maggioranza dei giovani europei e americani. Il mondo è diventato piccolo; girando per Seul si vedono i jeans strappati, i tagli di capelli, i volti che si incontrano a Roma o a Parigi.
Freddie ha i modi disinvolti da ragazza francese. Fa subito amicizia, è sicura di sé, disinibita. Propone a un ragazzo, che non se l’aspettava, di fare l’amore, ma non si lega a lui. Respinge con durezza il ragazzo coreano dopo che si è innamorato di lei.
Quando parla al telefono con la madre adottiva sembra infastidita dalla sua sollecitudine: «Dove sei? Non avevi detto che saresti andata in Giappone? Che cosa fai in Corea? Sta attenta!».
Si avverte la preoccupazione della madre adottiva per questo viaggio non programmato.
Casualmente, quasi senza pensarci (anche qui il caso l’aiuta a scegliere tra paura e desiderio) Freddie si mette in contatto con la società che gestisce le pratiche di adozione e, dopo molte esitazioni, chiede di conoscere i suoi genitori biologici.
Le ricerche negli archivi dell’istituto, il centro Hammond, hanno esito positivo.
Scopre che la madre e il padre biologici si sono separati. Alla richiesta di un incontro, effettuata attraverso il centro di adozione, il padre accetta, la madre non risponde.
L’istituto le fissa un appuntamento con il padre. Freddie deve recarsi, accompagnata dall’amica interprete, in una cittadina distante da Seul. Durante il viaggio in pullman, mentre è un po’ assopita, ha un impulso improvviso: si risveglia e chiede insistentemente all’autista di fermarsi, di cambiare direzione. Vuole tornare indietro.
È un momento di smarrimento; l’amica l’aiuta a calmarsi.
Suscita comprensibile angoscia la prospettiva di trovarsi di fronte a una parte di sé sepolta tra le esperienze confuse della primissima infanzia. Freddie sta per eliminare il mistero, per vedere il volto e scoprire i modi del padre biologico, che non potrà più immaginare, dovrà ricordare.
Credo emerga confusamente dalla terra di nessuno compresa tra inconscio e coscienza la paura della delusione. Tutto qua? Mio padre è questo piccolo uomo? Non è il cavaliere solitario, l’eroe, l’artista che avevo immaginato?
Il padre è un piccolo uomo, come i padri di tutti (di quasi tutti).
Freddie lo guarda con curiosità: ha formato una famiglia accogliente; sembra deluso dalla vita, tende a umiliarsi, non smette di piagnucolare, di scusarsi.
L’attore che interpreta il padre ha una bella voce. Nel film (al cinema) solo le parti in francese sono doppiate; quando parlano in coreano si sente la voce vera degli attori. Mi ha colpito la voce di Oh Kwang-rok, che interpreta il padre: è profonda, sembra venire da sotto terra.
Con il doppiaggio parziale siamo messi nella stessa difficoltà di Freddie, aiutati dall’amica interprete, quando c’è, o dalla moglie del padre, che conosce un po’ di inglese. In alcune situazioni sentiamo parlare in coreano, non ci sono sottotitoli, non ci sono aiuti. Capiamo tutto, grazie alle capacità espressive dei bravissimi attori. Anche il volto immobile da ragazza fredda e anaffettiva di Freddie, inquadrato opportunamente, comunica: noia, fastidio, distacco.
Il padre biologico si scusa in continuazione e tende ad alzare il gomito tenendo in mano un bicchiere contenente qualcosa di forte che ingoia in un sorso solo.
Accoglie la figlia francese in compagnia della seconda moglie, una donna dolce, delle due figlie, due ragazze silenziose, di sua madre, la nonna paterna di Freddie, una povera vecchia.
Anche la nonna, che sembra svolgere un ruolo importante nella famiglia tradizionale coreana, un ruolo affettivo, manifesta un forte rimorso nei confronti di Freddie.
Il padre la porta a visitare il paesino di pescatori dove è nato, le mostra l’isolotto dove giocava da bambino; vorrebbe agganciare alla sua realtà una ragazza che viene da un’altra storia, da un altro mondo.
Insiste per regalarle qualcosa, tra gli oggetti esposti sul marciapiede da una venditrice ambulante. Dai gesti si capisce che ci tiene molto, vuole che Freddie scelga qualcosa.
Lei sceglie un paio di ballerine, le scarpette che, rivela all’amica, odia. Le abbandonerà accanto a una panchina non appena si sarà liberata dalle figure ingombranti della sua famiglia biologica.
Insistono per trattenerla qualche giorno.
Il padre vorrebbe riprenderla con sé, trovarle un marito coreano, secondo un costume, credo, diffuso fuori delle grandi città, anche se non sembra di trovarci in campagna. Dalle immagini dall’alto si ha l’impressione che quella parte della Corea del Sud sia stata invasa da una colata di cemento. Solo il mare non è ricoperto da autostrade, fabbriche, uffici, torri, centri commerciali.
Di notte fanno dormire Freddie accanto alla nonna; la povera vecchia l’accarezza dolcemente e sembra particolarmente scossa dai rimorsi. Mormora preghiere, si lamenta, forse chiede perdono.
Capiamo che tutta questa sollecitudine non piace a Freddie. Non le piacciono le carezze, l’abbondanza di sentimenti. Il giorno dopo chiama un taxi per tornare a Seul.
È raggiunta dal padre davanti all’ostello dove dorme: l’uomo è disperato, ubriaco, fa scappare un ragazzo che Freddie stava per portarsi a letto. Le chiede di restare in Corea; lei lo allontana bruscamente.
Di questa vacanza non rimane nulla, nessun legame. Spariscono dalla vita della ragazza: l’amica interprete, i nuovi conoscenti, il ragazzo innamorato trattato malissimo, il padre avvinazzato e pieno di rimorsi, la famiglia appiccicaticcia.
La ragazza anaffettiva rompe ogni legame.
Passano due anni. Siamo di nuovo a Seul: Salone degli armamenti.
Freddie partecipa come “ragazza vetrina” (public relations) di un’industria impegnata nel commercio delle armi.
Ha studiato la lingua, è molto truccata; in un pub conosce un intermediario di affari francese che le piace; un po’ conversano, poi gli dice: «Una sveltina o andiamo in camera tua?»
È il compleanno di Freddie, un giorno malinconico in cui si fa sempre la stessa domanda: «In questo momento mia madre starà pensando a me?»
Passano altri cinque anni, siamo ai giorni nostri (2020 – ‘21): la gente indossa le mascherine.
Freddie ha ripreso contatto con la famiglia del padre; va in macchina a fargli visita insieme a un ragazzo francese, Maxime, con cui sembra avere instaurato un rapporto affettivo.
Ha avuto un incidente di macchina che le ha causato la frattura di una costola; per riattaccare i due pezzi i chirurghi hanno dovuto mettere un gancio. Fa vedere al padre la radiografia sul cellulare.
Il padre ha accettato la realtà, ha capito che Freddie può essere solo una gradita ospite francese; ha ridotto il consumo di alcol.
Forse un gancio ha riattaccato, bene o male, due parti separate di Freddie, la parte precedente all’adozione e la parte successiva. Al gancio manca la madre.
Alla fine del pranzo il padre fa sentire agli ospiti un pezzo musicale che ha realizzato con un programma al computer.
Freddie guarda il padre. Lo vede umile, timoroso di un giudizio; le fa pena.
Maxime dice: «Non male per un autodidatta».
In macchina al ritorno lei non vuole tornare in ostello con Maxime, preferisce restare sola. Gli dice: «Potrei cancellarti dalla mia vita schioccando le dita».
«Cosa?» risponde Maxime.
Lei ripete guardandolo negli occhi: «Potrei cancellarti dalla mia vita schioccando le dita».
Un altro legame è finito.
Una persona che ha vissuto la rottura del rapporto con la madre quando era totalmente dipendente da lei avrà sempre paura di riprovare il dolore della separazione. Il suo compleanno sarà il giorno più infelice dell’anno.
Finalmente Freddie ha la notizia tanto attesa: la madre biologica ha accettato di incontrarla.
L’incontro è tutto in primo piano. Si vedono i due visi, le mani della donna accarezzano il volto della figlia; lei accetta volentieri quelle carezze. Sono le carezze che le mancavano. È la prima volta che vediamo Freddie piangere. Forse è la prima volta che piange.
Alla fine dell’incontro la madre le passa un biglietto con un indirizzo email.
Un anno dopo.
Freddie sembra più giovane, ha tagliato i capelli, niente trucco, ha uno zaino sulle spalle, gira a piedi; si capisce che ha ritrovato se stessa. Vuole conoscere il paese dove è nata.
Entra in un albergo, chiede una stanza. L’impiegata dell’albergo legge i suoi dati sul passaporto e le dice: «Happy birthday».
È il compleanno di Freddie e questa volta non è un giorno triste.
In attesa che la camera sia pronta chiede di andare in bagno, si siede sul water, tira fuori lo smartphone, scrive un messaggio per la madre biologica. Le scrive che ora è tranquilla, felice.
Sullo schermo dello smartphone il traduttore istantaneo traduce in coreano.
Freddie copia l’indirizzo dal pezzo di carta che la madre le ha dato nel primo e unico incontro e invia.
Il sistema le comunica che non riconosce l’indirizzo: mail delivery eccetera.
Forse la madre biologica ha un problema che la costringe a evitare di far entrare nella sua nuova vita la figlia data in adozione. Però Freddie è riuscita a conoscerla, a conoscere entrambi i genitori: non sono più figure astratte e evanescenti, sono reali. Non sono immagini di un sogno. Non importa che il padre sia un uomo insoddisfatto, che la madre non possa o non voglia mantenere un legame con lei.
Tutti i figli devono emanciparsi dai genitori; ora può farlo anche Freddie.
Va verso l’uscita, vede un pianoforte. Si siede e comincia a suonare. Non sono sicuro (non sono esperto di musica), ma credo rievochi il motivo che ha in testa e ogni tanto le arriva come un ricordo da un altro mondo. Non so se sia questo un segnale che il regista mette a nostra disposizione.
Credo che nel commento ci sia molta interpretazione: non tutti vedranno ciò che ho visto io; altri spettatori vedranno cose diverse, che non ho visto. L’ho verificato. È normale, ma in questo film accade di più che negli altri. Il regista ci lascia indovinare i pensieri e i sentimenti dei protagonisti, ci permette di costruirli in base alle nostre esperienze. Va bene così.
Post precedenti sul cinema coreano
“Miracle: Letters to the President”, regia di Lee Jang-hoon;
“Next Sohee”, regia di July Jung;
“Cane che abbaia non morde”, “Barking dogs never bite”, regia di Bong Joon-ho.